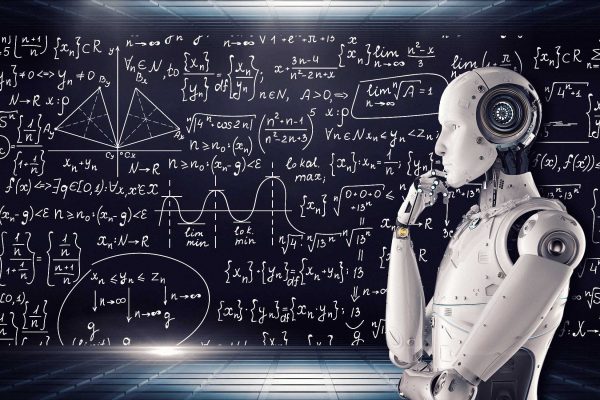Mi propongo di considerare la domanda: “Le macchine possono pensare?”. Si dovrebbe cominciare col definire il significato dei termini “macchina” e “pensare”.
Alan Turing, 1950
Io sostengo che valore è un concetto che conduce infallibilmente all’economicizzazione. Qual è il massimo valore? La risposta è se ho giustamente economizzato.
Carl Schmitt, 1967
È precisamente così, d’altronde, che la valutazione è entrata nella nostra vita quotidiana: tacita, neutrale, anonima (come lo sono in genere i valutatori, che si dice operino meglio al riparo di una trasparenza senza nome). Ci imbattiamo in essa di continuo e senza accorgercene: dai questionari sulla soddisfazione clienti alle pagine on-line valutazione-merito-trasparenza…
Valeria Pinto, 2012
…come ogni attribuzione di valore, la valutazione non è una misurazione scientifica e imparziale di una prestazione, ma un tipo di classificazione che dipende dal “punto di vista”, e dagli interessi, di chi valuta.
Alessandro Dal Lago, 2013
A quel punto mi sono ricordato: erano i globuli di marmo con cui si completava il resto nei supermercati cinesi [… ] non esisteva una piccola somma tanto capricciosa da non potersi pagare con quelli.
César Aira, 2014
In uno dei suoi ultimi romanzi, Il marmo (2014), lo scrittore argentino César Aira immagina che, in una Buenos Aires dei nostri anni, il protagonista, non circolando abbastanza monetine di piccolo valore, sia costretto dal titolare cinese di un supermercato dove ha fatto la spesa – avendo pagato con una banconota di grosso taglio – a scegliere fra la paccottiglia più misera oggetti sempre meno costosi per raggiungere il valore del resto che deve ricevere. Fino ad arrivare all’infinitesimale, all’innumerabile: a un certo punto, essendo il resto ancora da dare inferiore al valore della più piccola moneta legale in circolazione, il cassiere, spazientito ma rigorosissimo, gli dà alcuni piccoli globuli bianchi che sembrano fatti di marmo (scopriremo in seguito che si tratta di “pre-marmo”, uno strano materiale), e gli fa capire – con gesti e qualche parola smozzicata in presunto spagnolo – che può anche andar via.
Curioso imperativo, quello del cinese, di voler a tutti i costi dare un resto più che esatto al narratore: obbligo derivante dalla morale cinese? Incerta comprensione delle regole dell’economia politica (e domestica) occidentale? O semplice ossessione personale? La domanda, almeno inizialmente, rimane senza risposta, perché, appena uscito dal supermercato, il nostro narratore viene raggiunto da un ragazzino – cinese anche lui – lacero e macilento, che con un estremo senso di urgenza a gesti e con frasi semi-intellegibili gli fa capire, riferendosi ai globuli, che tutti e due devono correre a casa del protagonista. Da qui comincia un’avventura ai limiti del fantastico e dell’assurdo, come spesso capita con i romanzi di Aira (Santoro, 2015), in cui i presunti cinesi si riveleranno essere extraterrestri che vorrebbero tornare sul loro pianeta.
Pur invitando chi sta leggendo queste pagine a scoprire da sé come viene raccontato il resto della vicenda, non è tanto sul romanzo che vogliamo soffermarci, quanto su una delle sue implicazioni: la relazione fra la dimensione fantastica che aleggia sulla narrazione, e l’idea che si possa contare, numerare l’infinitesimale, rendere discreto, assoggettandolo alla legge del valore di scambio, ciò che appare virtualmente continuo: un valore inferiore alla sua minima unità.
Una contraddizione in termini insomma, se pensiamo invece alla necessità dello scambio economico di contare quantità discrete, numerabili, esatte: la logica dello scambio economico non può nutrirsi, o convivere, con quella – incommensurabile – dello scambio simbolico, ad esempio, che invece vive della inconfrontabilità fra gli oggetti – materiali o immateriali – che vengono scambiati.
Possiamo immaginare come la situazione in cui si trova metta profondamente in scacco il protagonista del romanzo, nato e cresciuto in un mondo in cui l’intero sistema degli scambi è intriso profondamente della legge strutturale del valore economico delle cose. La stessa dimensione, in fondo, è quella che governa il nostro rapporto con la sfera del digitale. Nella stessa misura, infatti, immersi come siamo – ormai – in questa dimensione, stentiamo forse a percepirne la pervasività, non dal punto di vista delle sue evidenze – la Rete, i cellulari, le schede elettroniche – ma da quello del suo essersi innervata talmente in profondità nel paesaggio della nostra esistenza da aver infiltrato, colonizzato, tradotto anche ambiti che a prima vista ne sono esclusi, non sembrano poter appartenere al suo raggio di azione, appaiono ancora ineffabili, dominio del continuo e dell’analogico, irriducibili al numerico, al discreto – vuoi per sentire comune, vuoi per tradizione, vuoi – anche – per etica.
Certo, ne discutiamo gli effetti “positivi” e “negativi”, il portato di benessere ma anche di costrizione; la contraddizione fra le comodità che ha introdotto nella vita quotidiana e i rischi di oppressione che produce… ma rimaniamo in superficie: ne vediamo gli epifenomeni, fatichiamo a vederne la natura profonda. Scrutiamo nel buio, ma ormai il grosso dell’universo digitale è nascosto in profondità. Non solo dei computer e della Rete, ma del sociale, dell’umano.
Siamo ossessionati dalla paura del controllo, del rischio di finire trasformati in lunghe sequenze di “zeri” e di “uno” nelle grandi banche dati dei server remoti, diventare piccole frazioni dei “big data”, trascurando il fatto che, una volta al computer – e in particolare online – siamo in un regime di scambio: non simbolico, ci mancherebbe, ma economico: uso la Rete gratis, fornisco dati gratis. Alle agenzie di ricerca, alle multinazionali della produzione e del consumo. Che sia uno scambio pari o impari, non è pertinente. Solo nelle teorie economiche liberali lo scambio economico e alla pari. D’altra parte il social network più frequentato, Facebook, mostra proprio questa reciprocità: i limiti che pongo all’esplorazione del mio “profilo” scandiscono i limiti che incontrerò nel visitare il “profilo” dei miei “amici”.
Oppure ci sfiora la paura di rischiare continuamente di suscitare l’interesse di qualche agenzia di “intelligence” che potrebbe spiarci, monitorarci, schedarci… Ne scrive Zygmunt Bauman nella sua conversazione con David Lyon in Sesto potere, ad esempio (2014; cfr. Fattori, 2014). Senza pensare che queste preocupazioni sono meno recenti di quanto normalmente, oggi, immaginiamo. Perché – forse – i più giovani non conoscono e i più anziani non ricordano la storia dell’ingresso e dell’affermazione dell’elettronica nelle nostre vite e nel nostro mondo. Pure, si tratta di una vicenda relativamente recente, trent’anni, o poco più: la storia dell’ingresso dei personal computer nelle nostre vite.
Siamo fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del XX secolo. Mentre nel 1984 Steve Wozniak e Steven Jobs, ancora ispirati dallo slogan “il potere del computer al popolo” mettono sul mercato il loro primo personal, piccolo e relativamente poco costoso (Odifreddi, 1994), nelle nostre case cominciano a penetrare i “Commodore 64” applicati allo schermo dei televisori, con i giochini come Poing e i primi videogiochi inziano nei bar a sostituire i vecchi “flipper”. Ma la penetrazione profonda, di massa, del digitale nella vita quotidiana è già iniziata, anche se è ampiamente opaca, nascosta, sotto traccia. Quando arrivano in casa i primi “personal”, l’ingresso dei computer nelle imprese già è avvenuto. Per gestire la contabilità, quella generale, quella elementare: l’intero “sistema informativo aziendale”, come recitano i libri di ragioneria. La burocrazia si digitalizza, almeno al livello delle aziende private.
D’altra parte, elaborazione elettronica dei dati e gestione d’impresa sono fatti l’una per l’altra: perché la gestione ha necessità di registrare e memorizzare i dati aziendali in un flusso, perché il computer serve per trascrive e ricordare dati. E perché tutte e due funzionano discretizzando dati, contando e numerando. Valutando, alla fin fine: le merci le imprese, i dati i computer. Il “cervello elettronico”, il “calcolatore”, fino a quel momento ammantato dell’aura di potenza e mistero quasi esoterici che riverberavano dall’apparato militare e dal mondo della ricerca scientifica, grazie anche all’immaginario tecnologico/complottista della narrativa di fantascienza e del senso comune, trova un impiego – già diffuso anche se non divulgato dai media – molto più prosaico, ma basilare per il sistema sociale: contare il denaro, registrare i movimenti di base del sistema economico, e gestire il flusso dei documenti aziendali. Quelli che a Harold Innis, il maestro di Marshall McLuhan (Bifulco, Vitiello, 2004), avevano dato l’ispirazione per cominciare a ragionare sul rapporto fra informazioni (dati) e valore (economico), fino, una volta diventata globale la Rete internet, a ricoprire il mondo, annullando il tempo e lo spazio, dei flussi di dati in continuo movimento delle transazioni finanziarie…
Non sorprende quindi se anche nelle scuole – e qui la storia personale di chi scrive si intreccia con quella di quei tempi – a partire da quelle per ragionieri, gli “Istituti Tecnici Commerciali” di allora, i computer comincino ad apparire come gli strumenti del futuro: è evidente che i ragionieri in formazione si ritroveranno ad usarli, è quindi chiaro che bisognerà introdurli. E con loro, entrano nelle scuole i programmi di contabilità aziendale, prima quelli “dedicati” alle imprese, poi quelli che le case editrici di “scolastica” allegheranno ai libri di testo. C’è una fatidica coerenza di fondo, una congruenza nucleare fra le esigenze – e la funzione – della contabilità d’impresa e il funzionamento del computer: la “discrezionalità” dei dati: l’unità di misura del valore di scambio è la moneta di conio, che ha un suo minimo irriducibile – il centesimo, ad esempio; quella dei pc è il bit. Al di sotto non si può andare, sono unità che non si possono frazionare ancora: il digitale trionfa sull’analogico, il discreto sul continuo.
Al momento della loro introduzione, le società che ne proponevano l’acquisto offrivano anche corsi di familiarizzazione con il loro uso: all’inizio, si imparava a programmare in Basic, ad esempio: si costruivano semplici “contatori”, ci si spratichiva con i “run”, gli “if, then”, ci si familiarizzava con la tastiera… si lavorava in Dos, poi con il pacchetto di programmi antenato di “Office”: “Wordstar”, “Lotus 123”, “Db3”, mentre si scopriva l’esistenza del “mouse”… Ma attenzione: fra il lavoro sui linguaggi di programazione come il Basic e il lavoro sui primi pacchetti applicativi già c’è un passaggio di stato nella consapevolezza e nella conoscenza del funzionamento del computer. Nel primo caso l’interfaccia di dialogo con la macchina è ancora pressocchè diretto: si programma; mentre usando un programma già pronto fra l’utente e la macchina c’è un filtro in più: un avvicinamento alla dimensione attuale, quella in cui il virtuale, la “realtà sintetica” (Caldieri, 2011) è una mimesi quasi completa della “realtà naturale”.
Siamo già, intanto, fra la metà degli anni Ottanta e il loro declinare. È in quel periodo che si entra nel mondo dei “diagrammi a blocchi”, o “di flusso”. L’estasi della discretizzazione: l’idea che i processi da realizzare, le catene di eventi, possano essere organizzati in termini di programmazione puntuale – e che quelli spontanei possano essere tradotti negli stessi termini – che i processi possano essere tutti ridotti a procedure. In fondo, la missione della cibernetica, già dal suo nascere: ridurre le sequenze di movimenti dei corpi a unità discrete, tradurle in termini algoritmici (le “trasformate”, cfr. Ross Ashby, 1971), e poi a partire da queste costruire macchine che le replichino, i robot.
Dal gesto, si passò alla parola: se potevano essere codificati/decodificati e replicati i movimenti, perché non provare a fare lo stesso con processi più… “immateriali”? In fondo, già la strada era indicata, con i programmi di gestione di una serie di procedure standardizzate… Perché non provarci anche col processo di insegnamento/apprendimento? Il modo in cui funziona il computer è seducente: la possibilità di suddividere un processo in fasi finite, separate, distribuibili lungo una linea è accattivante: perché non applicare la logica delle “macchine a stati discreti”, dei diagrammi a blocchi anche alla necessità, sempre più evidente, di ridurre un processo che, anche nella sua continuità, si percepisce come costituito di fasi successive? Perché non applicare – vista la crisi del discorso pedagogico e le difficoltà della scuola di adeguarsi al mutamento sociale – anche all’istruzione una “tecnologia” di organizzazione – di programmazione – del lavoro che potrebbe permettere di avvicinarsi di più ad una dimensione oggettiva, scientifica, della progettazione, monitoraggio, manutenzione e realizzazione degli obiettivi dell’istruzione? In fondo, già il percorso dell’istruzione dei ragazzini e degli adolescenti è scandito: dal flusso di prove orali e scritte, dai trimestri o quadrimestri, dagli anni scolastici, dalle soglie che periodicamente gli scolari devono superare… Una programmazione progettata per steps successivi, avendo chiaro l’obiettivo finale, definendo contenuti, metodi, obiettivi intermedi potrebbe rendere più oggettivo e fluido – e confrontabile e replicabile – l’intero processo. Perché al termine di ogni singolo passo, si potrà verificare se si sta procedendo bene, e andare avanti o replicare il già fatto.
If, then, Se, allora: se ho ottenuto il risultato vado avanti, se non lo ho ottenuto ritorno sui miei passi e rifaccio daccapo. Perfetto. Risolto il problema. Utilizzando la logica della programmazione elettronica. E quella aziendale: c’è poi tanta differenza fra queste procedure e quelle che sorreggono il rapporto fra piani aziendali preventivi e controlli budgettari? Diremmo di no: organizzazione di un piano previsionale, controllo periodico degli spostamenti dalle previsioni, aggiustamenti adeguati per raggiungere gli obiettivi che l’impresa si è data. Dalla registrazione dei “fatti aziendali”, la natura profonda della contabilità generale, al tentativo di progettare il futuro, la scommessa del controllo budgettario, per raggiungere gli obiettivi – economici, finanziari, patrimoniali – fissati dall’impresa. Il digitale e il numerario si sovrappongono, dialogano, da quando il primo ha fatto il suo ingresso nel mondo.
Una delle implicazioni degli studi di Alan Turing e John von Neumann (Fattori, 2015). Che hanno prodotto il mondo in cui viviamo, e che ci hanno condotto a un immenso, incalcolabile progresso – nonostante i disastri che hanno provocato. Come, d’altra parte, altre grandi scoperte e/o invenzioni: basta pensare ad Alfred Nobel, Marie Curie, Nikola Tesla, perfino. È una delle caratteristiche dell’umano, quella di declinare anche verso il Male, ciò che produce per produrre progresso, benessere, agio. E sarebbe fin troppo facile applicare queste riflessioni alla sfera in cui si sovrappongono, si mescolano, si ibridano realtà naturale e realtà virtuale.
Ma qui vogliamo tornare a considerare una particolare “provincia”, come avrebbe scritto Alfred Schutz, dei sistemi di assegnazione di senso alla realtà e all’agire sociale: la scuola. Ci si perdonerà, ma è necessario ritornare a un aspetto di quella che potremmo definire la storia “sommersa”, materiale, minima, dell’istituzione: quella che riguarda l’intreccio fra le ipotesi alla base delle “teorie” dell’educazione che si sono susseguite, la ripresa – in genere semplificata, superficiale – delle stesse da parte degli apparati istituzionali, la percezione delle stesse da parte del “sentire comune” degli insegnanti, e l’applicazione che questi ne facevano.
Parliamo di “valutazione”, in particolare. I più anziani di noi ricorderanno quando si passò dalla rigida “dittatura” del voto numerico alla “libertà” (?) del “giudizio”: assegnare alle prestazioni o al percorso di un alunno un valore numerico discreto, un voto da “zero” a “dieci”, per capirci, da un certo momento in poi fu considerato riduttivo, povero, conservatore, anche umiliante: non dava ragione della complessità della condizione umana in sviluppo, dell’unicità di ogni singolo individuo. Si passò ai “giudizi”, brevi descrizioni analitiche delle qualità dei singoli. Che però dovevano concludersi con qualcosa che sintetizzasse il tutto, un termine unico: “mediocre”, “sufficiente”, “buono”, e così via. Presto noi insegnanti – e i genitori, gli alunni, imparammo a “tradurre” questi termini in numeri: “sufficiente” = 6, “discreto”, = 7, etc. e – estrema vertigine della praticaccia del “mestiere” – presto imparammo a costruire i giudizi analitici in modo che precipitassero automaticamente nel numerino che, dopo alcuni mesi o un anno di lavoro, esprimeva secondo noi il valore scolastico di quell’alunno: il circolo vizioso dell’ipocrisia istituzionale si era così chiuso. E questo si è riflesso rapidamente su tutta l’architettura del rapporto fra prestazioni degli alunni e valutazioni delle stesse, fino agli esami di stato.

In gioco, insomma, è la definizione di un valore – spendibile sul mercato del lavoro, all’università, nella graduatorie di concorso, un valore discreto, numerabile, affine al valore di scambio. Mancava qualcosa: la esplicitazione e legittimazione del processo che avrebbe portato alla determinazione di questo valore. E lì entrò in gioco la logica, che abbiamo descritto più sopra, della “programmazione didattica”, il primato del diagramma a blocchi applicato al processo di insegnamento/apprendimento. In perfetta buona fede, sia chiaro: era, a quei tempi, necessaria e convincente, come proposta. Prometteva di rendere consapevole, trasparente, replicabile e confrontabile il lavoro di ognuno di noi.
Ma nascondeva un rischio, quello di trasformarsi da elemento di sviluppo delle pratiche didattiche ed educative in una sua catena. Non tanto di per sé, ma nella combinazione con il resto delle “tecnologie” connesse all’architettura del sistema di istruzione e formazione. Perché un sistema del genere richiede coerenza: un’organizzazione del lavoro didattico scandita in termini discreti richiede un sistema di valutazione altrettanto discretizzato. Il che significa che se il processo di insegnamento viene organizzato come un sistema di procedure finite, anche il sistema di valutazione deve adeguarsi. E non solo – o non tanto – nel suo sbocco finale, voto numerico o giudizio sintetico, ma nel meccanismo che genera il risultato, il voto finale. E così, cominciano a nascere e a crescere sistemi sempre più complessi e articolati di riduzione analitica di tratti ed elementi che dovrebbero fare da indicatori – oggettivi, per carità – degli elementi da porre alla base della valutazione: le conoscenze, i “saper fare”, i comportamenti, la “partecipazione”. Elementi che si pretende essere “osservabili”, quantificabili, misurabili… una vertigine del frazionamento che finisce per frantumare l’oggetto dell’analisi (l’alunno) in un’immagine caleidoscopica della descrizione dello stesso. Inconsapevolmente, la presunzione di arrivare – attraverso una combinatoria di unità elementari distinte e organizzate ordinalmente e gerarchicamente – a definire atteggiamenti attraverso comportamenti – nel definire qualità attraverso elenchi di quantità. Il tentativo di costruire una “macchina di Turing” virtuale che risponde positivamente alla domanda che lo stesso Alan Turing poneva all’inizio del suo articolo più famoso (1950), «Le macchine possono pensare?», e a cui sempre lui non dava risposta.
Nei fatti, a parte alcuni casi di tenacemente lodevole (e forse ingenuamente ossessiva) determinazione, si finisce – avendo già deciso, intuitivamente, sulla base dell’esperienza e del “mestiere”, un voto finale – per percorrere il sentiero al contrario, e costruire un ritratto costituito da elementi discreti appartenenti ad un vocabolario condiviso che conduca a quel voto. Una sorta di contabilità della formazione, parente della contabilità sociale perseguita da coloro che nutrono la loro ricerca di test, dati e statistiche, nell’elaborazione di un qualcosa che spesso è stata al servizio – o ha giustificato – le peggiori pratiche di macelleria sociale: del lavoro, del sociale – dell’apprendimento.
A rifletterci, l’obiettivo è la costruzione di un modello, anzi di un sistema interconnesso di modelli locali che producono un modello totale: si ha in mente un modello di scolaro, che dovrebbe essere prodotto attraverso l’applicazione di un modello di progetto e processo di formazione, praticato in un certo modello di scuola, da un certo modello di insegnante: l’estasi, l’utopia della burocrazia, ispirata ai modelli di funzionamento dei computer. E che naturalmente fa a pugni con la realtà concreta: quella delle nostre scuole, certo, ma prima di tutto quella dell’irriducibilità a un modello delle biografie e delle memorie personali, di per sé non interpretabili secondo un minimo comun denominatore. Quelle dei giovanissimi oggetto dell’istruzione, ma anche quelle degli insegnanti, che, pur impegnandosi ad applicare il nuovo modello, finiscono per riavvitarlo su se stesso, come giustificazione di un qualcosa – la capacità di valutare – che è percepito forse inconsapevolmente, ma decisamente (e per chi scrive, giustamente) come irriducibile a un qualsiasi modello.
Ed è interessante come, proprio negli anni subito precedenti a quelli in cui partiva questo processo, esattamente nel 1980, due ingegneri, Giuseppe Perrella e Raffaele Strino si trovavano a scrivere, riflettendo sulle trasformazioni indotte nell’organizzazione della produzione dalla diffusione delle “macchine simulanti”, come le definivano, e quindi del passaggio dal modello fordista a quello postfordista:
«Ora con la fase elettronica dell’industrializzazione, da forme di rappresentazione deterministe si è passati a modelli di simulazione che generano storie di eventi e di stati possibili, senza la necessità di un rapporto diretto col processo concreto. Quindi, il processo produttivo, mentre con l’industrializzazione meccanica veniva rappresentato e determinato, con la diffusione delle tecnologie elettroniche viene sempre più dedotto, previsto e regolato da modelli generativi. Modelli generativi in quanto modelli che incorporano e sintetizzano il processo concreto in forme astratte di conoscenza e di rappresentazione e quindi modelli che diventano mezzi che generano il reale. Il rapporto col processo produttivo, col sistema di macchine e di lavoro, diventa allora “il reale del modello”. Il calcolatore come medium afferma, infatti, l’impossibilità di ogni distinzione tra i reale e il modello» (Perrella, Strino, 1980, p. 18; corsivi nel testo).
Sarebbe difficile non percepire le similitudini fra i processi che si svolgevano nell’organizzazione della produzione e la prospettiva che si apriva nelle scuole. Convergenze forse dovute alla circostanza che il processo di riorganizzazione del modello di funzionamento dell’istruzione formale fosse stato ispirato a partire dagli indirizzi di studio che avevano un rapporto più diretto con gli sbocchi lavorativi (oltre ai tecnici per ragionieri, quelli per i periti chimici, i geometri…)? O onda lunga, di marea, che come questa si infiltra sulle spiagge sotto la sabbia intridendola senza che ci se ne randa conto, che ha incominciato a informare l’intera organizzazione – e la percezione – di tutti i rapporti sociali, oltre che quelli di produzione in senso stretto, dando vita ad una vera e propria mutazione antropologica?
In sintesi, la logica del modello, della trascrizione digitale del reale, diventa la forma con cui i rapporti sociali di produzione si ri-definiscono, si ri-organizzano e ispirano l’intera struttura sociale, nelle sue parti, e nel modo in cui questa pensa e dice se stessa, in una dimensione simulacrale che tende a rielaborare anche quegli aspetti dell’esperienza umana irriducibili al numerico, al discreto, dentro l’ordine dei simulacri, del modello. Dalla sfera dei rapporti affettivi (cfr. Illouz, 2013; Fattori, 2013), a quella della socialità, a quella della socializzazione secondaria, dell’educazione. È l’ossessione dell’oggettività, quella che imprigiona i nostri pedagogisti, sedotti da un ideale tecnocratico che vuole espandersi a conquistare l’intero scenario sociale, anche laddove questo appare inafferrabile, visto che, nel nostro caso, più inconsapevolmente che altro, è stato aggirato quasi al suo nascere da coloro che avrebbero dovuto applicarlo, che hanno ribaltato il processo e ne hanno raccolto solo gli aspetti più superficiali, gli output, per usare un termine ancora di moda: la necessità di una sintesi finale.
E non ci si deve far confondere dalla circostanza che – ormai – la digitalizzazione è entrata, o comunque sta entrando a velocità sempre maggiore nelle scuole: lavagne interattive, computer, tablet e quant’altro sono ormai di casa, sempre più insegnanti accettano o propongono ai propri alunni di “creare” “gruppi” su Facebook, o li stimolano a farlo sui social network che – c’era da aspettarselo – sono nati esplicitamente per la scuola: pudichi, “seri”, grigi, “didattici”, insomma – che gli alunni tendono naturalmente a ingorare, trascurare, disertare. Tutta questa dimensione è di pura superficie: è l’ultimo strato di una struttura “a cipolla” – quella che peraltro, naturalmente, all’opinione pubblica viene spacciata come di dimensioni ben più ampie e avvolgenti di quanto siano in realtà. La membrana esterna di una sorta di “complotto metafisico” che ricopre un reale ben più povero e abborracciato. Una vera e propria “narrazione” (Lyotard, 1981) – non “grande”, naturalmente, bensì piuttosto misera – della scuola italiana che apparati burocratici e personale politico somministrano agli utenti del servizio: quei contribuenti, elettori, cittadini che mandano i propri figli a scuola.
Un apparato in cui ancora i tratti dominanti sono quelli della scuola tardo-ottocentesca/primo-novecentesca (Fattori, 2012) messa insieme dai fantasmi del personale governativo sabaudo innervato degli eredi del personale amministrativo borbonico, in cui tecnici e educatori in buona fede (negli anni Ottanta del Novecento) cercarono di introdurre elementi di modernizzazione attraverso il ricorso – consapevole – alle “nuove tecnologie”, senza rendersi conto di lastricare la strada all’ingresso e alla legittimazione di tecnologie della formazione ispirate in profondità dalla logica – quella del postfordismo elettronico – che sta riscrivendo e reinterpretando su base digitale i rapporti di produzione e i rapporti sociali nel loro complesso, e che, dopo una trentina d’anni, hanno lasciato il posto alla presunzione di aspiranti tecnocrati di apparato che hanno portato alle ultime conseguenze questo processo di riduzione dell’educazione – promozione di talenti, vocazioni, affinità, curiosità, creatività, tutte qualità non numerabili – a elementi scanditi, finiti, controllabili, maneggiabili con facilità: misurazione di competenze e conoscenze, abilità e stili ricavabili dalla somministrazione di batterie di test, questionari e quant’altro. Il tutto mentre gli stessi paesi che avevano costruito questi marchingegni li hanno messi da parte riconoscendoli – alla prova dei fatti – né affidabili né produttivi.
Torniamo alle origini dei processi che stiamo analizzando. Ancora Perrella e Strino, riferendosi sempre all’informatizzazione dell’industria e della produzione in generale scrivevano: «E tali modelli, si badi bene, non si rapportano al processo produttivo e al mercato secondo una funzione rappresentativa: il modello non ha la funzione di designare e/o ordinare il reale. Il reale viene sempre più dedotto, previsto e interpretato attraverso modelli di simulazione: con l’egemonia del lavoro-morto sul lavoro-vivo si sono create le condizioni perché la produzione possa darsi fondamentalmente come genesi del modello» (cit., p. 17, corsivi nel testo).
Il che significa che, con la riduzione di un oggetto analogico, (il lavoro vivo) ad un oggetto digitale (il lavoro morto incorporato nelle macchine e nei computer), i modelli di simulazione cercano di descrivere la continuità del reale in termini discreti, spacciando poi il risultato della modellizzazione come realtà. In pratica, i modelli di simulazione che trascrivono la logica della produzione al tempo dell’egemonia elettronica, trasformano questa in genesi di se stessi, e così si legittimano di fronte alla dialettica fra capitale e lavoro – diventando modello di lettura e motore di mutamento, c’è da aggiungere, per tutti i rapporti sociali, quelli delle “relazioni industriali” come anche quelli degli apparati di socializzazione secondaria.
Analogamente, in termini per così dire “cibernetici” (Ross Ashby, cit.), la presunzione dei sistemi di misurazione e valutazione dell’apprendimento è quella di trascrivere un processo di per sé analogico in termini digitali, pretendendo poi di “restituire” la dimensione analogica dello stesso processo. Trascurando che, necessariamente, in questo andirivieni si perde in informazione: quelle giacenti nel discontinuo, nell’infinitesimale, nel non numerabile. Non abbiamo, come i cinesi/alieni di Aira, “globuli” di “pre-marmo” da utilizzare per evidenziare l’infinitesimale.
In più, applicati alle concrete organizzazioni dell’istruzione, questi sistemi devono fare i conti con le situazioni “locali”, storicamente e socialmente determinate: modelli magari perfetti nella loro autoreferenzialità si infrangono contro il muro di gomma di una burocrazia inerte e farraginosa, e di un personale di base da una parte consapevole delle proprie prerogative, dall’altro preso in contropiede dalle pretese di innovazione – pretese spesso poco credibili, castelli di cartapesta dalle fondamenta di carta velina.
Schiacciati fra la cattiva coscienza di chi sa di non avere strumenti adeguati e l’istanza etica di fornire un servizio dignitoso, gli insegnanti per anni si sono affannati a costruire griglie e schede di misurazione e valutazione sempre più raffinate e a “definizione”, per così dire, sempre più “alta”, che tentassero di render conto del percorso e dei traguardi degli alunni cercando di isolare elementi significativi, numerabili, ispirati alla logica della discretizzazione dei dati. Una battaglia inutile, che si conclude, sistematicamente, con una sorta di salto mortale: si parte da quel che si – in mancanza di vocaboli migliori – “sente” dell’alunno in termini di valore “didattico”, e lo si giustifica scegliendo le voci giuste nelle griglie che si sono adottate. Pratica naturalmente condannabile, illegittima, che mina alla radice decenni di “ricerca didattica”, qualsiasi cosa questo voglia dire, ma che è nella maggior parte dei casi la risposta più adeguata a questa patafisica – al ribasso, e priva di qualsiasi creatività e ironia – della valutazione imbastita dalle agenzie istituzionali, a partire da quell’Invalsi (pomposamente Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione), uno dei bracci burocratici secolari degli ultimi governi e del Miur, che è fra i maggiori responsabili dell’attuale degrado dell’istruzione – universitaria e scolastica – italiane.
Alla base la sussunzione, di fatto orgogliosamente e solo vagamente mascherata, alla logica del valore di scambio (cfr. Dal Lago, 2013; Pinto, 2012): il tentativo di appiattire ricerca scientifica e insegnamento/apprendimento ad una dimensione aziendalistica, attraverso la digitalizzazione in profondità del processo di valutazione della conoscenza e della sua crescita. La realtà – rimaniamo ancora alla scuola – viene ricoperta da una membrana – quella del discorso sulla scuola – in cui le cosiddette “nuove” (ormai hanno mezzo secolo…) tecnologie dell’informazione sarebbero motore di innovazione e modernizzazione. Dentro questa membrana, un cumulo di rovine, in cui adolescenti alieni alla nostra scuola (loro sì, “nativi digitali”) scalpitano interdetti o assenti per ore in uno spazio/tempo in cui la forza delle poche – e estemporanee – tecnologie digitali è costretta dentro un’organizzazione della didattica che è ridotta al fantasma di se stessa, grazie alle continue ristrutturazioni degli insegnamenti, delle riduzioni del numero di ore per disciplina, dell’eliminazione di alcune materie d’insegnamento gabellate come innovazione, ammodernamento, alla totale estraneità al mondo in cui viviamo: continue picconate alle pareti di un organismo che pure aveva una sua coerenza, ricoperte con stucco di cattiva qualità.
Il tutto, senza vedere assolutamente le persone cui si sostiene di rivolgersi, adolescenti e preadolescenti del terzo millennio, che vivono nel terzo millennio, nella società della rete e della connessione: «La vera crisi del sistema della formazione consiste allora non già nel suo non riuscire a rimanere fedele al passato disciplinare e monomediale, ma nel suo essere ancora costitutivamente chiuso al mondo» (Pireddu, 2010).
Ancor più dentro, il vero livello dove la logica del digitale opera, le procedure di misurazione e valutazione dell’apprendimento: i sistemi di cui abbiamo già detto, supportati e nutriti, ormai, dall’adozione del “registro elettronico” – naturalmente quello approvato dal Ministero. Altro elemento di polemica e confusione. Accolto con estrema diffidenza, ideologicamente respinto per i rischi di “controllo” sul lavoro degli insegnanti che si ritiene implicare, in realtà non ha nulla di diverso da quello cartaceo – anche quello poteva essere “sequestrato” dalla gerarchia e controllato – nella pratica è addirittura più flessibile: è possibile modificare senza che ne rimanga traccia anche il passato, anche i dati già inseriti. C’è da pensare che le critiche dipendano dalla scarsa conoscenza, o dalla paura di non saperlo usare per la propria scarsa dimestichezza con tastiere, mouse e schermi…
Ben venga, quindi. Anche perché contiene la “prova”, se vogliamo usare un termine da crime fiction, delle considerazioni sviluppate sopra, fra l’altro proprio laddove si dovrebbe completare tutto il processo di insegnamento/apprendimento dando conto dell’unicità di ogni singolo alunno: la definizione dei giudizi con cui si ammettono gli alunni agli esami di stato, il momento in cui – evitando schemi predefiniti e formule standardizzate – i docenti dovrebbero costruire un “ritratto” del candidato. Bene, oltre a prevedere la costruzione di un voto numerico come sbocco dei voti assegnati durante l’anno, la tecnologia del registro elettronico prevede un’area in cui, in una semplice matrice a doppia entrata, in orizzontale sono proposti gli items relativi ai tratti che sevono alla valutazione (quelli “scoperti” faticosamente in quasi mezzo secolo di “ricerca didattica”) come “impegno”, “profitto”, “partecipazione”., “metodo di studio” – di per sé, tranne il “profitto”, difficilmente quantificabili – e in verticale una serie di formule predefinite che, combinate insieme incrociando le due dimensioni, sfociano in quei “giudizi sintetici” in uso ormai da decenni (“sufficiente”, “discreto”, e così via)…
In pratica, la definitiva sussunzione (sotto traccia: parlarne “parrebbe brutto”, “mortificherebbe” la “missione” dei docenti) della unicità degli individui contemporanei ad una combinatoria di segni – spesso “senza referente”, come scriveva Jean Baudrillard agli albori delle riflessioni sulla società dei simulacri (1984) – come quelli che servono a costruire “profili” confrontabili e scambiabili sui vari mercati contemporanei: quello degli affetti (Illouz, cit.), quello della cultura, quello del lavoro. E d’altra parte, il giudizio finale, agli esami di stato, ormai è il risultato di un astruso algoritmo fatto di griglie “nidificate” fra loro, che vengono riempite di valori numerici, e poi vengono “tradotte” in giudizi finali fatti di formule ormai codificate. Sembra l’applicazione del “test di Voight-Kampff” al contrario (Dick, 1971), per controllare se gli alunni siano sufficientemente aderenti ai modelli che sia gitano nelle teste dei valutatori…
Anzi, a pensarci bene, proprio sul tema del lavoro precipitano e si falsificano tutte le ideologie e le costruzioni teoriche che ruotano attrono alla valutazione, e nella maniera più banale possibile: per avere dati sulle tecnologie, gli apparati, i processi di insegnamento/apprendimento, piuttosto che costruire astruse e autoreferenziali macchine per il calcolo del valore “scolastico” degli alunni, basterebbe controllare, un paio di anni dopo il diploma, che fine hanno fatto questi: il percorso universitario se hanno continuato a studiare, lo sbocco lavorativo se hanno deciso di cercare un impiego. Ma qui… qui, nel confronto fra le “promesse” della “nuova” (e fra poco “buona”) scuola e gli esiti dell’istruzione, cascherebbe, nel modo più classico, l’asino delle burocrazie della formazione, nell’abisso infinito del disinteresse per i progetti di vita (Beck, 2008) delle giovani generazioni attuali.
Davanti ai nostri occhi, alla nostra percezione, una gigantesca “macchina simulante”, una lumpennarrazione fatta di mezze verità, manipolazioni e bugie messe in scena dalle nostre burocrazie ministeriali e dalle nostre élite politiche.
Per approfondire:
- Aira C., Il marmo, Sur, Roma, 2014.
- Baudrillard J., Le strategie fatali, Feltrinelli, Milano, 1984.
- Bauman Z. e Lyon D., Sesto potere, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- Beck U., Costruire la propria vita, il Mulino, Bologna, 2008.
- Bifulco L. e Vitiello G. (a cura di), Sociologi della comunicazione, Ipermedium, S. Maria Capua Vetere, 2004.
- Borrelli D. e Di Cori P. (a cura di), Rovine future, Lampi di stampa, Milano, 2010.
- Caldieri S., Spazi sintetici, Liguori, Napoli, 2011. Dal Lago A., All’indice, in “aut aut” 260, 12/2013.
- Dick P.K., Il cacciatore di androidi, Nord, Milano, 1971.
- Fattori A., Alla scoperta dell’acqua calda, in “Quaderni d’Altri Tempi” n. 41, 2012.
- Fattori A., Ti/tubare e soffrire, in “Quaderni d’Altri Tempi” n. 46, 2013.
- Fattori A., Sorvegliare e contare, in “Quaderni d’Altri Tempi” n. 48, 2014.
- Fattori A., Segreti di Sua Maestà o di Pulcinella?, in “Quaderni d’Altri Tempi” n. 54, 2015.
- Illouz E., Perché l’amore fa soffrire, il Mulino, Bologna, 2013.
- Lyotard J.F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1981.
- Odifreddi P., Cibercreduloni, in “La Rivista dei libri” n. 5, Milano, 1994.
- Perrella G. e Strino R., Le macchine simulanti, Theorema, Roma, 1980.
- Pireddu M., Dentro le mura. Educare e comunicare arretrando nel futuro, in Borrelli, Di Cori (a cura di), 2010.
- Pinto V., Valutare e punire, Cronopio, Napoli, 2012.
- Ross Ashby W., Introduzione alla cibernetica, Einaudi, Torino, 1971.
- Santoro L., A Sud, sì. Ma di quale universo?, in “Quaderni d’Altri Tempi” n. 53, 2015.
- Turing A., Computing Machinery and Intelligence, “Mind” n. 49, 1950.