Partiamo da un tema che sembra solo apparentemente scollegato dagli argomenti del tuo libro. La scorsa estate prima Richard Branson e poi Jeff Bezos hanno compiuto i loro primi, brevi voli di turismo spaziale dimostrando le capacità delle aziende aerospaziali che hanno messo su. Bezos, in particolare, ha ringraziato tutti i lavoratori e gli acquirenti di Amazon perché grazie a loro ha potuto realizzare il suo sogno di andare nello spazio. Una frase molto criticata, a causa della crescente alienazione del lavoro che Amazon introduce nei suoi stabilimenti. Il nostro futuro spaziale è destinato a essere guidato un pugno di miliardari a cui va il merito di aver trovato il modo finora più efficiente di impiegare capitale e lavoro?
Da un certo punto di vista sì: in Technosapiens parlo molto della questione delle disuguaglianze che stanno crescendo a dismisura e il turismo spaziale, se vogliamo, è proprio un simbolo fortissimo di questa dinamica. Abbiamo una persona come Jeff Bezos che ha grosso modo dichiarato che grazie ai lavoratori di Amazon (che sono – lui non l’ha aggiunto, ma lo aggiungiamo noi – malamente sfruttati) ha potuto realizzare il suo sogno d’infanzia di andare nello spazio. Probabilmente lui non si rendeva nemmeno conto di quello che stava dicendo, ma stava letteralmente affermando che, grazie al lavoro di centinaia di migliaia di persone che sono sfruttate, lui, uno solo, l’uomo più ricco del mondo, ha potuto realizzare il suo sogno d’infanzia.
Al di là del caso specifico, il turismo spaziale, oltre a essere ovviamente molto affascinante – perché lo è, è inutile negarlo, come lo è l’idea di esplorare Marte, magari colonizzarla – è un sintomo di un mondo che si sta dividendo in due a una velocità che nell’epoca moderna non si era mai vista e che pensavamo che tutti gli sforzi di uguaglianza, welfare e così via ci avrebbe permesso di lasciare alle spalle. Invece, il turismo spaziale sarà ancora una volta e ancora più delle crociere di lusso e di tutto ciò a cui siamo già abituati, un mondo fantastico creato solo ed esclusivamente per i super ricchi che, quindi, possono abbracciare le meraviglie del mondo tecnologico e ultratecnologico cui stiamo andando incontro sulle spalle di persone che, invece, questo mondo tecnologico lo subiscono per poter lavorare sempre di più, e così elaborare le risorse che servono per rendere tutto ciò possibile.
 Nel tuo libro – e anche nella risposta precedente – affermi sostanzialmente che l’innovazione tecnologica e digitale abbia tradito la sua promessa di liberarci dal lavoro, o perlomeno di farci lavorare molto meno. In effetti, dalle teorie di John Maynard Keynes in avanti, si è sempre sostenuto che l’introduzione delle tecnologie nelle nostre vite avrebbe aumentato il tempo libero e ridotto le ore di lavoro, ma così non è stato. Cosa è andato storto?
Nel tuo libro – e anche nella risposta precedente – affermi sostanzialmente che l’innovazione tecnologica e digitale abbia tradito la sua promessa di liberarci dal lavoro, o perlomeno di farci lavorare molto meno. In effetti, dalle teorie di John Maynard Keynes in avanti, si è sempre sostenuto che l’introduzione delle tecnologie nelle nostre vite avrebbe aumentato il tempo libero e ridotto le ore di lavoro, ma così non è stato. Cosa è andato storto?
Non sono un economista, ma credo che l’idea di Keynes, poi rielaborata da tanti, fosse a suo modo perfettamente logica: ammettendo che l’obiettivo economico di una società sia di mantenere un certo livello di produzione, grazie all’automazione inevitabilmente si ridurrà il lavoro richiesto dalle persone perché ci si potrà appoggiare a strumenti tecnologici sempre più avanzati. Quello che, invece, mi sembra di capire stia avvenendo è che per meccanismi inevitabili, insiti nel capitalismo, bisogna inseguire una crescita economica che deve continuamente, necessariamente, essere in crescita, in salita. Per stare dietro a questa crescita che sta sfuggendo alle dinamiche naturali di una società, siamo costretti a adoperare la tecnologia per estrarre sempre più valore dall’essere umano, quindi il contrario di quello che gli economisti di primissimo livello, come Keynes, non avevano, forse, previsto. Ovvero, il fatto che l’Uomo avrebbe dovuto produrre talmente tanto che le tecnologie non lo avrebbero liberato, ma gli avrebbero permesso di arrivare a questo livello estremo di produzione.
Un altro pensatore che mi viene in mente, anche se è un nome un po’ controverso, è Ernst Jünger, che parlava dell’inesistenza del tempo libero, di come nella società moderna anche il tempo libero fosse perfettamente adattato agli scopi del capitalismo (probabilmente non lo diceva lui, ma lo diciamo noi). Da questo punto di vista il meccanismo del capitalismo di piattaforma è perfetto, perché anche in quello che per noi sarebbe tempo libero, in realtà stiamo producendo valore per altri: nel nostro tempo libero e per buona parte di esso non facciamo cose oziose e improduttive, ma attività che producono valore per altri. Stare su Facebook o Instagram a produrre dati e materiali che creano ricchezza è perfettamente funzionale a un capitalismo di piattaforma in cui le persone lavorano senza neanche rendersene conto. Non so se a livello economico sia una definizione corretta, ma io credo che nel momento in cui sto producendo valore, da un certo punto di vista sto lavorando.
Da questo scenario viene spontanea una domanda: si può immaginare in qualche modo un modello di sviluppo tecnologico al di fuori delle maglie del tardo capitalismo? Se sì, in che modo lo potremmo realizzare?
Difficilissimo dire come lo potremmo realizzare, però penso che la risposta sia comunque positiva. Facciamo una premessa: nel momento in cui determinate tecnologie vengono sviluppate – come è sempre stato nel caso del mondo occidentale – all’interno di un determinato sistema economico, è inevitabile, anzi direi è necessario, che quelle stesse tecnologie siano funzionali al sistema economico che le ha progettate. Sarebbe assurdo il contrario, per cui noi oggi viviamo non solo nel realismo capitalista di Mark Fisher, ma anche in una sorta di realismo capitalista tecnologico in cui non riusciamo più a immaginare un mondo in cui tutte queste tecnologie digitali dalle quali siamo circondati non sia funzionale alle dinamiche di cui abbiamo parlato poco fa, ma siano funzionali al benessere degli utenti.
Secondo me, poter immaginare un funzionamento diverso è uno dei principali vantaggi dell’accelerazionismo. Quando parlo di accelerazionismo – lo premetto – parlo di una teoria esagerata, per certi versi utopistica, addirittura assurda, ma che ha un grandissimo vantaggio: ci aiuta a pensare al di fuori della scatola, ovvero ci aiuta a mettere la testa al di fuori di questo sistema che vediamo come inevitabile e obbligatorio, e ci apre una finestra su un mondo in cui il sistema tecnologico ed economico funziona in maniera diversa. Come dovrebbe funzionare? Un esempio concreto è quello del cooperativismo di piattaforma, in inglese Platform cooperativism: una sorta di esproprio proletario del codice. Un esempio classico è quello di Uber: si costruisce una piattaforma alternativa e concorrente a Uber in cui però i profitti vengono reinvestiti e ridistribuiti tra tutti quelli che partecipano alla piattaforma. Ci sono stati tentativi di creare alternative di questo tipo e non hanno mai funzionato perché per qualche ragione, anche intuibile, ovvero mancanza di risorse da poter reinvestire, tutti questi strumenti non lavorano mai abbastanza bene da poter attrarre utenti che non siano fortemente ideologici. È pur vero, però, che almeno ci dà l’idea di come sia possibile – se ci fosse una volontà politica – cambiare la dinamica. Esistono strumenti per far sì che queste tecnologie diventino molto più a servizio dei cittadini di quanto non siano oggi. L’accelerazionismo ha il grande vantaggio di delineare un quadro a 360° e parlo ovviamente del Manifesto di Alex Williams e Nick Srnicek in cui tutto questo, anche se in maniera utopistica, ci dà un orizzonte al quale guardare.
Lo scorso agosto Mark Zuckerberg ha pubblicato un post in cui scriveva “Stiamo lavorando al Metaverso, la prossima evoluzione di Facebook” e tutti hanno cominciato a riprendere questo tema. Tutti i grandi player digitali e tecnologici vogliono iniziare a gettarsi nel grande business di questa nuova evoluzione di Internet. Questo ambiente virtuale e immersivo dove potrebbe trasferirsi tutto ciò che oggi svolgiamo in digitale, e dove potrebbero trovare piena cittadinanza concetti oggi ancora esotici come le valute digitali e i non-fungible token, rappresenta un’ulteriore evoluzione di quel percorso che tratteggi in Technosapiens in cui mondo fisico e digitale si fondono? E sarà un’ulteriore tappa verso un web sempre più proprietario?
Sia Internet che il web sono nate come piattaforme open, non proprietarie e quindi decentralizzate, aperte a tutti, ed è ciò che ha permesso l’evoluzione straordinaria di questa tecnologia. Se Internet fosse stata proprietaria e ci fosse oggi un CEO di Internet o del World Wide Web ci saremmo scordati di questo sistema così aperto, ricco e che ha dato la possibilità ai vari Facebook di nascere. Per cui la prima cosa che mi viene da pensare è che un Metaverso che sia necessariamente chiuso e recintato, in cui tante piccole aziende costruiscono i loro piccoli recinti, nasce da un certo punto di vista già zoppo, perché nasce senza la possibilità di creare veramente un mondo, ma solo tanti piccoli recinti in cui ciascun utente è chiuso all’interno del recinto che sceglie. È un po’ quello che American On-Line e altri grandi produttori statunitensi avevano cercato di fare all’inizio con Internet, fallendo miseramente, perché l’esperienza dell’utente non ne traeva vantaggio.
Un altro aspetto ancora più interessante è che l’idea di futuro in cui il mondo fisico e il mondo digitale si fondono che ho immaginato e che ho descritto nel libro, è un mondo in cui la base è costituita dal mondo fisico: un mondo fisico sul quale innestiamo, attraverso l’esempio classico di visori a realtà aumentata, uno strato ulteriore di vita digitale. Per cui, se oggi questi due mondi sono sempre più affiancati, non sono ancora compenetrati. Per poter fare quest’intervista tramite Skype mi sono comunque dovuto sedere davanti a un computer; con i visori a realtà aumentata magari starei passeggiando e potrei farlo con lo smartphone. Quindi questi due mondi – fisico e digitale – oggi sono solo affiancati, anche se, appunto, già viviamo on life come direbbe Luciano Floridi, ma anche compenetrati hanno comunque come base il mondo fisico. Invece l’idea a cui sta lavorando Facebook è l’opposto di quello che Kevin Kelly ha chiamato Mirrorworld: è qualcosa per cui andiamo a vivere in un mondo digitale, una sorta di Second Life alla milionesima potenza. Qui il pericolo che vedo è che il vantaggio di un mondo digitale e fisico che si fondono grazie allo strumento della realtà aumentata è quello di avere, da un certo punto di vista, il meglio di due mondi con tutti gli effetti collaterali e negativi che ci sono e di cui parlo abbondantemente in Technosapiens.
Finora la maggior parte della nostra attenzione si è rivolta ai GAFA, ossia al gruppo dei Big Tech che stanno plasmando il mondo occidentale attraverso le nuove tecnologie. Ma i BAT cinesi non sono da meno, con l’aggravante che in Cina, come mostri nel tuo libro, non ci sono quei correttivi democratici che finora hanno impedito a certe soluzioni – come l’applicazione su larga scala del riconoscimento facciale – di diffondersi. Pensiamo a un Metaverso realizzato dalla Cina…
Questa osservazione mi fa venire in mente una cosa che aggiungo come postilla alla risposta precedente, ovvero che ho anche il timore che questa ambizione del Metaverso non sia un caso che emerga in epoca di pandemia, proprio perché forse la paura della pandemia o, comunque, delle condizioni climatiche sempre più estreme e del fatto che il mondo in cui viviamo stia diventando sempre meno ospitale per svariate ragioni, stia spingendo, invece che verso investimenti per far sì che rimanga almeno un minimo ospitale, su enormi risorse per crearsi una sorta di mondo digitale abitabile dove rifugiarsi quando i lockdown saranno magari la normalità, perché sappiamo che i virus potrebbero tornare. Sono probabilmente una conseguenza del sovraffollamento della Terra e di tutto ciò che ne consegue; quindi, il SARS-CoV-2 potrebbe non essere una cosa che si verifica tra cent’anni, ma potremmo doverci abituare a una sequenza di avvenimenti di questo tipo a cui poi si aggiunge, ovviamente, la crisi climatica. Il timore è che questi grandi poteri della Silicon Valley stiano guardando a una prospettiva in cui devono creare un ecosistema digitale alternativo.
Per quanto riguarda la Cina, loro vanno nella nostra stessa direzione a un livello macro-tecnologico con la differenza che non si occupano minimamente dei temi della privacy, come osserva Simone Pieranni in Red Mirror. È come se fosse parte di quel grande scambio che c’è stato tra società e politica: crescita economica in cambio di libertà… e ovviamente anche di privacy, che della libertà è un elemento cruciale. Nel momento in cui questi grandi colossi digitali prendono potere, lo fanno in una maniera ancora più indiscriminata di quello che avviene dalle nostre parti, dove quantomeno si cerca, anche se con molta fatica, di far sì che tutte queste tendenze tecnologiche siano almeno oggetto di discorso, dibattito e critiche. Oggi leggevo, per esempio, che le nuove misure di Apple di controllo della pedopornografia, che io ho aspramente criticato, ma che altre persone con ragioni altrettanto valide hanno accettato, hanno creato disappunto e che alcuni dipendenti stanno iniziando a ribellarsi a questa cosa, cercando di fermarla. Tutto ciò in Cina non esiste, per cui quello che succederà è che la Cina sarà sempre di più un nostro specchio sul futuro. Già oggi sta avvenendo… uno specchio distopico sul futuro, una sorta di Black Mirror a cui noi possiamo guardare per vedere quali sono le possibili derive pericolose delle tecnologie che anche noi stiamo adottando.
Tutto questo vale ovviamente finché Internet è globale, perché c’è anche la questione del decoupling della Rete. Viviamo in un mondo in cui tutti siamo connessi perché le grandi potenze non avevano calcolato quali sarebbero stati gli effetti collaterali di questa connessione globale, cioè il fatto che siamo tutti vittime e soggetti ad attacchi che possono giungere da qualunque parte del mondo. Secondo me lo scenario al quale andiamo incontro è quello chiamato Splinternet, ossia una balcanizzazione della rete, in cui sempre di più ci saranno delle “isole di rete” tra Paesi alleati e che continueranno a scambiarsi informazioni, ma che si separeranno da tutte le altre. L’Iran sta studiando un modo non per separarsi attraverso grandi firewall, ma proprio per separarsi fisicamente dalla rete occidentale, tagliando i cavi. Secondo me, man mano che la rete diventa un’infrastruttura strategica, è quasi inevitabile che si vada in questa direzione.
Ma questa è anche una reazione a una crescita di cyberattacchi? Ci dobbiamo aspettare, nei prossimi anni, che il fenomeno degli attacchi cibernetici aumenti? Alcuni ne parlano come di un prossimo rischio globale, “la pandemia di Internet”, in considerazione dell’aumento su larga scala di attacchi informatici a Stati, grandi aziende e così via.
Già oggi sono quasi la normalità. Approssimativamente tutte le grandi aziende sono costantemente vittime di attacchi hacker. C’è poi la questione dello spionaggio industriale, dello spionaggio militare, degli attacchi alle infrastrutture strategiche che si verificano in maniera più sporadica, ma sempre più frequente. C’è stato anche il caso di Triton, il malware che un paio di estati fa ha attaccato un impianto di produzione energetica in Arabia Saudita che, potenzialmente, poteva causare delle vittime. La situazione sta, quindi, diventando sempre più seria e sempre più un’arena di guerriglia, una cyberwar. Sì, penso che questa sia una prospettiva già oggi esistente e che non potrà che crescere perché tutto si sta spostando sul versante digitale e inevitabilmente anche le azioni di spionaggio e di boicottaggio e militare si spostano sul piano digitale.
Credo che proprio per questo la questione di tagliare i collegamenti Internet che oggi hanno reso la rete globale sia quasi inevitabile, un po’ come gli spazi aerei sono protetti proprio per evitare che ci possano essere attacchi: bisogna chiedere i permessi, ci sono zone sulle quali non si può volare, le no-fly zone. Credo che una dinamica di questo tipo sia sempre più una dinamica con cui tratteremo Internet. No-fly zone significa chiudere alcuni collegamenti con determinati Paesi. Analogamente, ci saranno isole completamente staccate e ci saranno alleati con i quali avremo comunicazioni libere, come oggi con aerei civili possiamo sorvolare questi paesi. Probabilmente il paragone è un po’ forzato, ma l’idea è che anche Internet diventerà sempre più soggetta a quelle che sono le regole che oggi regolano i rapporti tra gli stati e non sarà più possibile accedere ovunque. Già oggi non lo è più e temo che lo sarà sempre meno.
Qual è la tua idea delle criptovalute? Che futuro ha la questione criptovalute e dell’economia dei token in questo scenario di Internet che stai delineando, con regole che cambiano per adattarsi anche alle innovazioni digitali? È qualcosa che è destinato a restare? Se sì, per quali obiettivi e in che modo?
Questo è un tema al quale effettivamente penso molto, perché lo trovo estremamente appassionante. Da un certo punto di vista vale un po’ il discorso che facevo prima: in un mondo in cui tutto si sta digitalizzando e in cui gli attori privati raggiungono sempre più un potere equiparabile a quello delle Nazioni, ha perfettamente senso che si innesti una moneta attraverso la blockchain, che non è ovviamente di proprietà privata perché, come Internet non ha un proprietario, non è controllabile dagli Stati. È questo che fa impazzire di gioia e di ottimismo tutto il mondo della Silicon Valley, ovvero l’idea che ci sia per la prima volta nell’epoca moderna una privatizzazione anche della moneta che si sposi perfettamente con un ecosistema globale. L’idea di una moneta che potrebbe diventare nativa di Internet. Jack Dorsey, il fondatore di Twitter che sui Bitcoin sta puntando tantissimo, ha detto di vedere nei Bitcoin non solo una riserva di valore digitale, ma proprio la moneta di Internet (ovviamente superando alcuni limiti tecnici).
Se dovessimo cambiare direzione, recuperare determinati valori che farebbero deviare il percorso della nostra società in questa direzione che sta andando sempre più verso un capitalismo estremo delle disuguaglianze, io non so quale possa essere il futuro dei Bitcoin. Vedo però i Bitcoin come lo strumento che si presta perfettamente alla direzione in cui il nostro pianeta sta andando adesso, cioè una moneta che permette a pochi di arricchirsi tantissimo, che si presta perfettamente a essere utilizzata dai magnati della Silicon Valley per la digitalizzazione del futuro e che da questo punto di vista privatizza la moneta, sottraendo ulteriore potere agli Stati. Poi c’è tutto il discorso di Ethereum che non è soltanto una moneta, ma una piattaforma che permette l’implementazione di strumenti molto interessanti, ad esempio permette di fare scommesse o fare finanza, prestiti, certificati per l’arte digitale, tutta una serie di attività che fino a oggi si potevano svolgere solo in alcuni ambienti controllati da istituzioni centrali, e che passano invece ad essere governati da algoritmi automatizzati. Anche questo credo sia qualcosa che si innesta perfettamente nella dinamica estrema di digitalizzazione verso cui la nostra società sta andando. Se la direzione resta questa – e, sottolineo, mi auguro non sia così – credo che le criptovalute abbiano un ruolo da giocare. Poi credo che se fossero state un fuoco di paglia, sarebbero già scomparse.
Una delle considerazioni più interessanti del tuo libro è quella riassunta nel sottotitolo “Come l’essere umano si sta trasformando in macchina”. Mentre i nostri sforzi si concentrano sul tentativo di sviluppare intelligenze artificiali in grado di imitare in modo sempre più verosimile l’intelligenza umana, al tempo stesso i nostri comportamenti sono sempre più simili a quelli delle macchine, fondati sugli stessi concetti di efficienza e ottimizzazione degli algoritmi. Come nasce questo paradosso? C’è un modo per evitare che l’essere umano si trasformi in una macchina?
Vale un po’ quello che dicevamo prima: sicuramente c’è, però al momento stiamo andando dritti sparati in quella direzione senza neanche pensarci troppo. Spesso quando parlo di questi temi in pubblico mi viene chiesto qual è la ricetta per fermarli. Io ripeto sempre che una ricetta non ce l’ho, non ne ho la più pallida idea, altrimenti mi lancerei in politica. È al di là delle mie capacità. Quello che so è che, però, c’è stata un grande cambiamento negli ultimi anni. Siamo reduci da dieci anni in cui abbiamo accettato tutti questi processi tecnologici senza renderci conto del fatto che presentavano anche degli effetti collaterali, perché non li riconoscevamo, non comprendevamo il loro funzionamento e non li avevamo ancora sperimentati. Ci bevevamo con un’ingenuità totale – anch’io per primo – quello che era lo storytelling proveniente dalla Silicon Valley… Tutta questa visione magnifica da ideologia californiana. Adesso che abbiamo visto e stiamo iniziando a capire e sperimentare sulla nostra pelle quelli che sono gli effetti collaterali, stiamo anche iniziando ad essere molto meno ingenui, per cui anticipiamo alcune cose e riusciamo a fermare alcune dinamiche che all’epoca non saremmo riusciti a fermare.
Penso al tema del riconoscimento facciale in Europa e negli Stati Uniti. Quando nacque, ci fidammo di chi ci diceva che sarebbe stato privo di qualunque errore e che avrebbe reso la società più sicura senza avere assolutamente alcuna controindicazione. Oggi invece, più pronti di quanto saremmo stati dieci anni fa, siamo stati in grado di capire come funziona, quali sono i suoi limiti, quali sono gli effetti collaterali anche in termini di sorveglianza e, quindi, almeno in Europa, siamo riusciti ad arginarne e limitarne fortemente l’utilizzo. Siccome io ritengo la sorveglianza un elemento fondamentale della macchinizzazione dell’essere umano, perché la sorveglianza tecnologica rende l’essere umano più conforme e quindi meno spontaneo, più simile a una macchina, credo che questa sia una storia costruttiva. Veniamo da dieci anni di ingenuità totale che ha permesso ad alcuni processi tecnologici di installarsi sulla nostra società senza nessun controcanto: oggi abbiamo una maggiore consapevolezza che ci sta permettendo di arginare alcuni fenomeni. Se questa consapevolezza riuscirà ad aumentare e a diffondersi con attenzione, allora forse potremo innanzitutto arginare e poi anche proprio deviarne il corso e far sì che l’uso della tecnologia non trasformi l’uomo in macchina, ma lo liberi da determinate frustrazioni a cui oggi è soggetto.
Technosapiens. Come l’essere umano si trasforma in macchina è edito da D Editore.
Si ringraziano Imma Erbaggio e Mariagrazia Manna per l’attività redazionale.

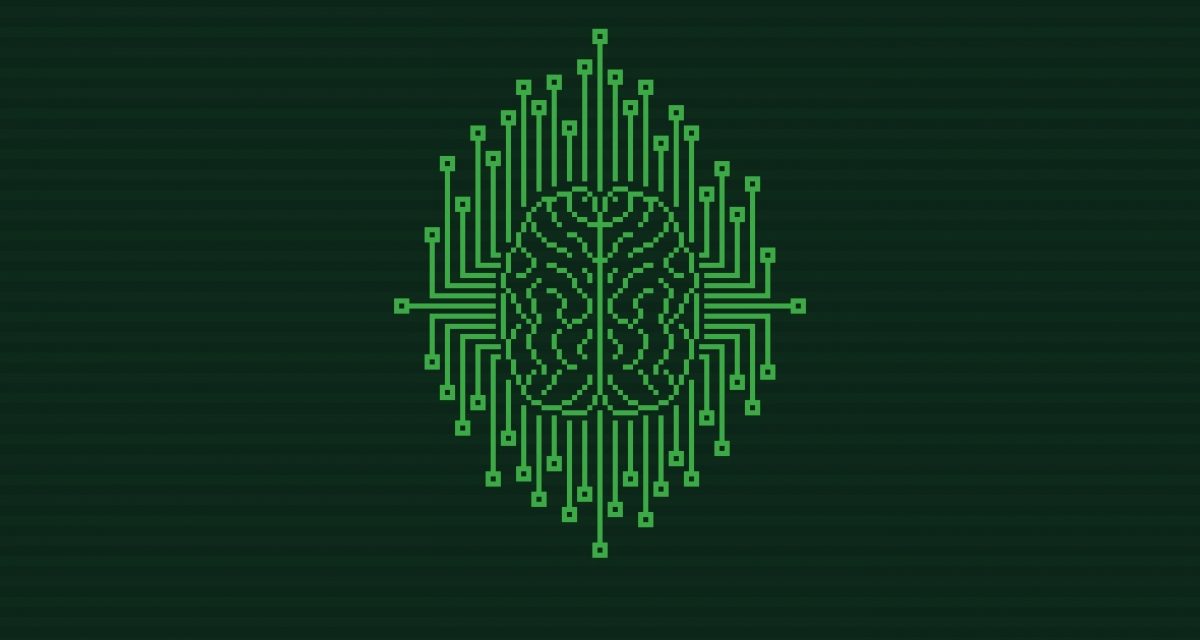









Grazie x i notevoli spunti sulla deriva elitaria che ha preso l’innovazione digitale.