È possibile “ricordare il futuro”? Sembrerebbe una domanda da film di fantascienza, ma per la sociologia è una domanda sensata. Si può ricordare infatti un particolare tipo di futuro immaginato – da una persona o da un gruppo sociale – in un determinato momento; tutti noi facciamo piani per il futuro, più o meno a lungo termine, molti dei quali per la verità destinati a non realizzarsi. Ricordare i possibili futuri che avevamo progettato per noi, per i nostri figli o per la nostra comunità (è il caso, per esempio, dei decisori politici) è un esercizio da cui si possono trarre utili elementi per il presente. Lo crede Paolo Jedlowski, uno dei più influenti sociologi italiani, che negli anni ha attraverso una serie di temi dell’indagine sociologica (la teoria sociale, la vita quotidiana, la memoria) per approdare recentemente sulle sponde di quella materia dai contorni ancora poco delineati che è la sociologia del futuro. Nel suo breve ma denso saggio Memorie del futuro. Un percorso tra sociologia e studi culturali, appena pubblicato da Carocci, Jedlowski – oggi docente all’Università della Calabria – pone una serie di spunti di riflessione per la ricerca futura che abbiamo scelto di ripercorrere insieme a lui con quest’intervista.
Qual è il collegamento che l’ha portata dai suoi precedenti studi allo studio della sociologia del futuro, e in particolare al tema della “memoria del futuro”?
La spinta è venuta soprattutto dai lavori che ho fatto sul tema della memoria. Occupandomi delle memorie collettive e anche individuali mi sono accorto – io così come tantissimi altri colleghi – di essermi occupato specialmente di memorie traumatiche, cioè del ricordo di dolori, di cose negative: ricordo che in molti casi è necessario conservare per poter elaborare il passato stesso, affinché non si ripeta nel futuro tale e quale. A un certo punto, però, ho sentito che dimenticavo un aspetto delle memorie, vale a dire il ricordo non solo dei dolori ma quello anche delle speranze; mi sembrava una lacuna, e del resto, siccome il tema del futuro, e anche il tema delle speranze più o meno futuribili, mi sembrava comparire nella discussione pubblica sensatamente, oggi, ho cercato di applicare quel che sapevo sulla memoria a un aspetto particolare: le memorie dei futuri desiderati.
Ora, nessun futuro desiderato o immaginato si realizza mai tale e quale; ci sono disillusioni, naturalmente. Ma in ogni caso il futuro si realizza dall’intersezione di infiniti progetti, speranze, molteplici attori ecc. A partire da questo desiderio di mettere a fuoco anche le memorie positive, mi sono ritrovato con una nozione di valenza generale: memorie del futuro. In realtà possono essere considerati non solo i futuri carichi di speranza, ma anche quelli progettati, i futuri temuti e così via. Così ho cercato di mettere a punto una nozione che in realtà può essere usata in diversi contesti, aiuta a fare ricerche in molti campi, per esempio nella storia sociale, o in antropologia.
 Qual è lo stato della sociologia del futuro a livello internazionale e in Italia? Si può definire una disciplina ancora pionieristica?
Qual è lo stato della sociologia del futuro a livello internazionale e in Italia? Si può definire una disciplina ancora pionieristica?
Se parliamo dell’argomento “memorie del futuro”, in effetti ho visto che mi hanno invitato a scrivere (e ne sono lieto) su questo tema in un Handbook of Memory Studies, in un Handbook of Future Studies, come a dire che altri non l’avevano effettivamente messa a fuoco. Se parliamo di sociologia della memoria, ovviamente è invece un campo attraversatissimo, sia in Italia che all’estero; se parliamo di sociologia del futuro, forse oggi è più praticato all’estero, specie in campo anglosassone, sebbene in Italia ci siano delle eccezioni importanti: un’autrice come Carmen Leccardi ha scritto molto di sociologia del tempo e si è occupata ampiamente del futuro, specie delle rappresentazioni del futuro presso i giovani oggi; o ancora, dentro i cosiddetti futures studies, dal punto di vista sociologico c’è un autore come Roberto Poli che è attivissimo, e anche a livello teorico sta portando avanti delle cose interessanti per concettualizzare il futuro.
Nel libro lei riprende la distinzione di Niklas Luhmann tra “presenti futuri”, ossia i momenti che devono ancora avvenire, e il “futuro presente”, ossia il futuro che immaginiamo attualmente. In che misura il futuro presente determina il nostro agire quotidiano?
Per Luhman i “presenti futuri” rappresentano il futuro vero e proprio, quello che ci sarà domani; invece il “futuro presente” è il futuro che oggi, ora, noi ci rappresentiamo. Il mio interesse, in effetti, è per questo secondo: il futuro che ora ci immaginiamo. Lei ricorderà con me quel concetto di Merton, le profezie che si auto-adempiono. Merton diceva che, quando noi ci aspettiamo una cosa, ci comportiamo in conseguenza di questa aspettativa, e a volte succede che così la rendiamo reale: per fare un esempio banale, se ci aspettiamo che una persona sia ostile nei nostri confronti, assumiamo anche noi un atteggiamento ostile, ma così l’altro diventerà effettivamente nostro nemico. Il nostro agire è influenzato dagli orizzonti di attesa che coltiviamo.
C’è un bellissimo libro, Il dolce avvenire, curato da dei giovani studiosi italiani (Deriu, Bosi, Pellegrino): loro dicevano che è importante immaginare i futuri peggiori, perché immaginandoli ci diamo da fare per evitarli. D’altra parte, aggiungevano: se si agisce solo per paura, è una cosa un po’ triste; pertanto, bisogna affiancare alle immagini dei futuri peggiori, l’immagine dei futuri migliori: un dolce avvenire. Anche questo influenza il nostro agire: possiamo cercare di far sì che un futuro migliore si manifesti.
Il concetto di “orizzonte di attesa” che lei utilizza nel saggio si riferisce tanto alle attese (ossia all’insieme di aspirazioni, progetti e previsioni) del singolo individuo che della collettività. È possibile che, all’interno di una singola nazione, vengano a collidere più orizzonti di attesa? E in tal caso cosa dobbiamo aspettarci?
Il futuro è per definizione incerto, quindi che cosa sia possibile, probabile, impossibile, è oggetto di discorsi, discorsi che circolano. Ebbene, in ogni società ci sono molti attori e gruppi sociali, che in parte competono intorno alla definizione dei futuri probabili, possibili, impossibili. Perché competono? Proprio perché quelle rappresentazioni sono performative, cioè hanno influenza: se mi aspetto che una certa cosa è impossibile, la rendo impossibile; se dico invece che un certo futuro è quello probabile, genererò altre conseguenze.
Effettivamente nel discorso pubblico, in ogni società, si sviluppano le “egemonie” di certi discorsi piuttosto di altri. Oggi c’è un discorso egemonico che dice che l’unico sistema economico plausibile è questo, quello di mercato, capitalistico, dunque tutti i “futuri possibili” che hanno a che fare con questo sono possibili davvero; altri sono impossibili, non vale nemmeno la pena di pensarci. Però, per ogni narrazione egemonica, c’è sempre anche una contro-egemonia, cioè altre versioni, e tra queste certamente vi sono conflitti. Direi che, sì, i conflitti nelle rappresentazioni del futuro esistono, direi che sono persino marcate oggi.
Lei definisce l’idea di progresso una “grande narrazione” del futuro, a lungo egemonica. Perché a suo giudizio oggi non ha più senso e andrebbe sostituita? Ed è possibile fare a meno dell’idea di progresso senza cadere nel pessimismo apocalittico o accettare esclusivamente l’ideologia della decrescita?
Nel libro cito Pierre-André Taguieff, un autore francese contemporaneo, che dice che possiamo continuare a usare la nozione di “progresso” se gli togliamo la maiuscola; cioè, se non lo pensiamo come una legge della storia, e soprattutto se non pensiamo che il progresso sia una cosa unica, che in modo solidale si esprime in processi economici, educativi, sanitari ecc. In realtà ci sono possibili “progressi”, al plurale e senza la maiuscola: in diversi ambiti della vita possiamo valutare cosa sarebbe meglio per noi ed eventualmente “provocarlo”. In realtà quel che è veramente in crisi oggi è la nozione generale di progresso, che è stata decisiva nella modernità. È in crisi su due versanti diversi. Il primo lo spiegherei con questa domanda: “Il progresso c’è, ma varrà anche per me?”. È una domanda un po’ tremenda, perché l’idea del progresso, della modernità, è sempre stata inclusiva. Certo, sappiamo che il progresso genera anche malesseri, disagi, problemi, ma tutti stiamo andando verso il meglio, e quindi ciascuno troverà il suo posto. Alcune persone con cui parlavo mi dicevano che il progresso oggi c’è, è evidente per esempio nella medicina, nelle tecnologie; il problema è però: oggi, nel regime economico mondiale neoliberista, sarò tra quelli che potranno godere di questi progressi, oppure ne sarò escluso? Questa è una domanda che genera sentimenti preoccupanti, per esempio il risentimento: mi era stato promesso qualcosa, ma la promessa non è stata mantenuta; avevo conquistato certi beni, certe posizioni, e ora mi vengono tolte, o c’è il rischio che qualcuno me le tolga. Molti conflitti sociali in chiave risentita nascono da questo tipo di riflessione sul progresso, ossia la percezione che il progresso ci sia ma non sia inclusivo, sia solo per alcuni.
C’è poi un secondo versante della crisi del progresso, che è invece più vasto e riguarda tutti. È una percezione cominciata nel 1986 con l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl: non quindi la bomba atomica che potrebbe scatenare la fine dell’umanità, ma una tecnologia nucleare usata per scopi pacifici che però comporta dei rischi di distruzione di portata planetaria. Allora il progresso tecnologico mostra un aspetto negativo; e questo poi si è associato alla percezione sempre più diffusa degli effetti che il tipo di crescita che abbiamo perseguito ha generato sul pianeta: al di qua della distruzione atomica c’è la distruzione in corso delle risorse naturali, il fatto che consumiamo di più di quello che si riproduce. Qui il problema è più vasto, perché la crisi dell’idea di progresso diventa la crisi di una certa idea di progresso, quella che si è appoggiata solo su una crescita senza limiti. Ma anche qui, si può non buttare via l’idea di progresso, ma dire che il progresso consiste piuttosto nel migliorare la nostra capacità di prenderci cura del mondo: sarebbe di nuovo un progresso, ma un’idea differente di progresso. Intorno a questo siamo in tantissimi a riflettere.
L’idea di progresso coltivata dalla generazione del 1968, di cui lei discute nel libro, era in effetti molto diversa; lei sostiene che l’orizzonte di attesa condiviso da quella generazione non abbia trovato riscontro nell’epoca attuale, in cui a dominare è invece un’altra visione del presente e del futuro, rappresentata dall’ideologia neoliberista. Perché il futuro dei movimenti generati dal ’68 non si è realizzato, e qual è la sua eredità nel mondo di oggi?
Credo che il ’68 sia un momento molto importante su cui bisogna ancora pensare: fu un insieme di movimenti che ebbero grandi aspirazioni, e aspirazioni rispetto alle quali l’idea di progresso veniva mutata; a parte che non era molto usata questa parola, ma è vero che eravamo figli di quell’idea (dico “noi” perché ero giovanissimo, ma c’ero). Avevamo aspirazioni a un tipo di progresso che non era solo tecnologico o solo di benessere materiale, pensavamo piuttosto a progressi istituzionali, come quelli che poi in gran parte si sono realizzati: pensiamo allo statuto dei lavoratori, al sistema sanitario nazionale, a una serie di cambiamenti nel costume, nelle leggi relative alla famiglia, al genere e così via. Quindi effettivamente un’idea di progresso differente, pur restando sempre dell’idea di qualcosa di meglio per il futuro; credo che sia ancora interessante analizzare quelle aspirazioni, perché in realtà sono ancora molto presenti e diffuse, anche se magari meno visibili: in fondo sono aspirazioni che hanno a che fare con un “individualismo solidale”, che è il contrario dell’individualismo competitivo che oggi è più visibile, quello che si è imposto.
Dove il ’68 probabilmente sbagliò un sacco fu nelle previsioni, e in questo senso è abbastanza ovvio che quello che ci si aspettava non si sia realizzato, perché in fondo facevamo innanzitutto una cattiva sociologia, che non teneva conto di tutti quelli che nelle aspirazioni che i movimenti portavano non si riconoscevano affatto. Noi ci auto-proclamavamo “avanguardie”, ma l’avanguardia deve tenere conto degli altri, dei loro bisogni, delle loro rappresentazioni del senso della vita. In fondo fummo – direi adesso, dopo tanti decenni – settari e intolleranti verso chi non la pensava come noi. Pensavamo che ci avrebbero seguiti comunque, ma senza capire da dove venivano, cos’altro pensavano, cose che magari valeva la pena considerare.
Questo è quel che dico in Memorie del futuro, poi ci sono altri pensieri che si possono fare. Per esempio, oggi ritengo che il leninismo – che era l’idea più generalmente organizzativa allora presente – comporti un invito alla lotta armata e un’organizzazione politica verticistica che hanno effetti devastanti, contro-intenzionali: la violenza chiama la violenza, e chi si addestra alla violenza poi dopo è un leader rovinato. Non mi aspetto che una rivoluzione politica violenta generi dei cambiamenti positivi. Questo è un pensiero personale, maturato negli anni: penso che molto si può cambiare, in fondo gli esseri umani hanno e si sono cambiati sempre, nel corso della storia; cambiamenti che comportano la violenza, però, riportano secondo me al punto di partenza, cambia magari chi comanda, poco altro. In fondo credo che i veri cambiamenti siano culturali, nel modo in cui ci si atteggia verso la vita, l’esistenza (nostra e degli altri): sono molto più lenti ma avvengono anche con strumenti molto diversi rispetto al conflitto.
Nel libro lei discute anche del ruolo che le utopie possono avere nell’elaborazione degli orizzonti di attesa collettivi. Il XX secolo è stato un secolo di utopie che non hanno mantenuto le loro promesse: c’è ancora spazio per nuove utopie?
Io credo che l’utopia sia qualcosa di prezioso. Il problema è usarla bene: se s’intende l’utopia come qualcosa che può essere letteralmente realizzato, ci si condanna al fallimento, perché un’utopia è uno stato futuro, immaginato, ma immaginato da qualcuno, quindi necessariamente una proiezione parziale, una certa idea di bene, di idillio, che però, se altri hanno altre idee di bene e di idillio, evidentemente poi o genererà un totalitarismo che li esclude o produrrà conflitti. L’utopia è una rappresentazione fantastica e tale va considerata.
Ma detto questo, perché è preziosa? Perché ci fa agire. Credo che bisogna stare attenti a non confondere l’utopia con una meta: credo sia piuttosto una “stella polare”; se la si tratta così ci aiuta a orientarci, ad andare in una certa direzione. Se la si tratta come una meta, allora ci si aspetta che sia raggiungibile, ma appunto si cade nel problema dell’interpretazione letteralista. Io credo che l’utopia sia preziosa, inoltre, perché immaginarla è un esercizio benefico, perché in fondo è una grande educazione al “possibile”, ci rammenta che siamo capaci di pensare una situazione diversa da quella presente, ma comunque possibile, che corrisponde alle proprie aspirazioni.
Ci sono molte persone molto sobrie intellettualmente, non particolarmente rivoluzionarie, che usano l’espressione “utopie concrete”. C’è per esempio un libro di un sociologo importante, Erik Olin Wright, che si chiama Envisioning Real Utopias: lui dice che sì, certo, l’utopia reale è un po’ un ossimoro, ma che se noi abbiamo un’idea di ciò che è meglio, possiamo intanto fare dei passi in quella direzione. In tal modo magari già costruiamo qualche situazione migliore, e poi ci si mette in rete, si va avanti, si incontreranno ovviamente degli avversari, ma si proverà ad affrontarli, a convincerli. Pensare utopie è quindi un esercizio per il possibile. In Emilia Romagna una sociologa molto brava, Vincenza Pellegrino, sta portando avanti un progetto chiamato Future Lab, laboratori del futuro: uno dei passaggi del laboratorio è di provare a immaginare la propria utopia; ma il laboratorio non si ferma lì, immagina anche distopie – ciò che non si vuole assolutamente – e poi alla fine sollecita a cercare i passaggi ora presenti nella direzione più desiderata. Non si vuole raggiungere l’utopia, ma pensarla fornisce quell’energia e quella capacità per individuare che cosa intanto oggi si possa fare per andare verso la direzione auspicabile.
Al contrario oggi però assistiamo alla crescita di una tendenza opposta a quella delle utopie: non solo la distopia, ma la nostalgia, il ripiegamento sul passato, reso idealizzato nella memoria. Possiamo interpretare l’ascesa dei nazionalismi e dei populismi in Europa in questi anni come l’effetto di un discorso nostalgico?
La nostalgia può essere intesa in più modi. C’è la nostalgia cosiddetta “restauratrice”, quella che prende alla lettera la nostalgia stessa: voglio quella cosa che ormai è passata. Questo genera un inganno, non solo perché non si può ritornare indietro, ricostruire condizioni passate, ma anche perché la memoria “abbellisce”: si ha nostalgia di qualcosa e si dimentica di cosa non andava bene in quella condizione. L’altro modo di usare la nostalgia è invece emancipatrice: la nostalgia che rammenta un desiderio e non ci dice “ricrea qualcosa di passato” ma “vedi che c’è qualcosa che tu desideri? Bene, adesso, fallo!”; magari fallo imparando qualcosa dal fatto che le condizioni che una volta ci furono poi si sono perse; indaga e impara dal perché quella condizione si è persa: la prossima volta, desidera meglio.
La nostalgia del passato porta o a revanchismi, cioè a movimenti politici di stampo reazionario, o a chiudersi nel rimpianto, nell’oramai: “oramai” è un’espressione che sento molto in giro, però è un’espressione che ti blocca, mentre in fondo tutto può essere costruito intorno a un’altra espressione, il “non ancora”. È molto diverso, è una questione di interpretazione di ciò che è stato: ciò che è stato “oramai” non ci sarà più, oppure ciò che è stato “non è ancora” quello che vorrei. Forse non è compito di un sociologo, però diffondere l’idea che certi atteggiamenti sono più utili di altri, o alcuni meno produttivi di altri, mi sembra sia una cosa utile da fare.
È legittimo parlare di “crisi del futuro” per la società occidentale contemporanea? Prevalgono i discorsi dell’oramai anziché quelli del non ancora?
Quello che prevale è in genere il discorso più vistoso, che ha più voce, che si diffonde di più, ma che non è per forza quello più diffuso veramente. D’altro canto, l’espressione “crisi del futuro” è tremendamente ambigua: in realtà i discorsi prevalenti oggi parlano di futuro, ma solo in una direzione: domani avremo un computer ancora più potente, un treno ancora più veloce, i robot e così via. Il punto è che sono futuri di un solo tipo, che prevedono cioè sviluppi tecnologici entro un solo tipo di cornice di politica economica, o di economia politica (usare l’economia per certi scopi).
In questo senso, quel che appare un’enorme enfasi nel discorso pubblico sul futuro è veramente una crisi del futuro, perché è una sola rappresentazione. Chi invece non condivide l’idea che avere più tecnologie sia proprio una meraviglia si sente al contrario in crisi nella propria percezione del futuro; ma si tratta solo di lavorare, di prendere atto di quanti si è a desiderare altri futuri: futuri inclusivi, pacifici, futuri dove la dignità degli uni non sia presente a scapito di quella degli altri. C’è uno spazio enorme per un lavoro propriamente politico, che è l’educazione al possibile: in questo senso, bisogna riaprire il futuro per chi se lo sente chiuso.

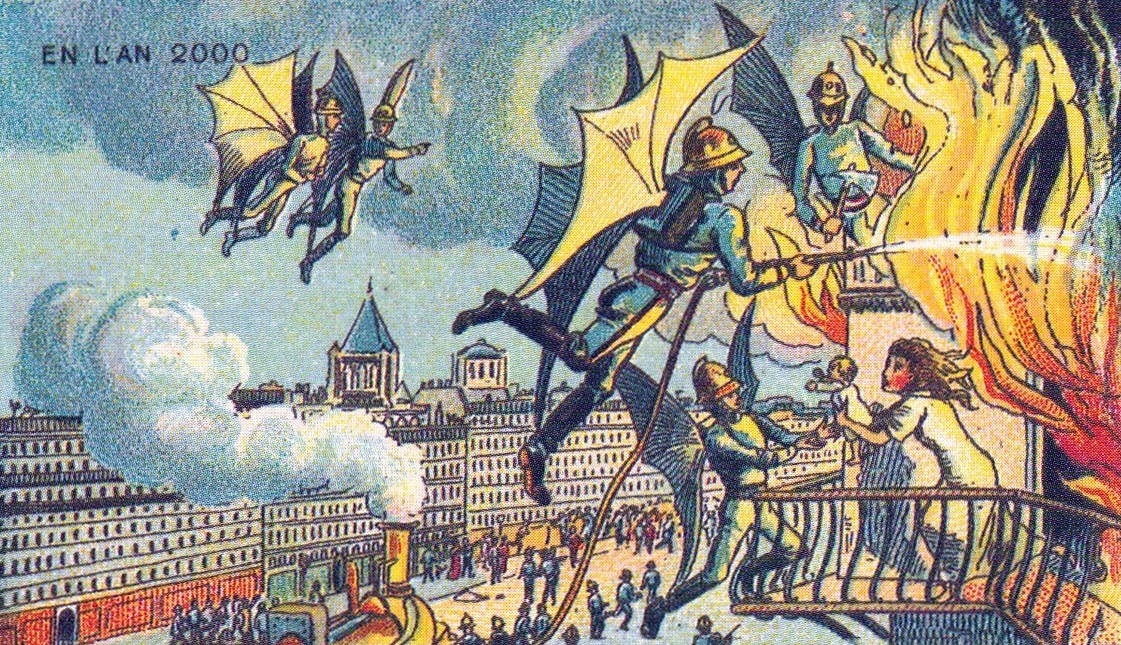












[…] possibile avere memoria del futuro. In un bellissimo articolo sul sito dell’Italian Institute for the Future, Roberto Paura – presidente […]