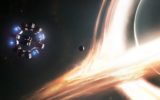Sebbene sia sempre esistita la possibilità per la specie umana di estinguersi a causa di un cataclisma o di fenomeni naturali come le glaciazioni (secondo alcune teorie, circa 75.000 anni fa la nostra specie si ridusse ad appena qualche migliaio di individui), la percezione di questo rischio è emersa solo molto recentemente, come effetto dello sviluppo di tre fattori:
- La crescente consapevolezza dell’interdipendenza tra la specie umana e la biosfera e la percezione dell’umanità come specie planetaria.
- L’affermarsi della teoria delle estinzioni di massa e la comprensione dei meccanismi estintivi.
- L’emergere di una civiltà tecnologica e di strumenti sviluppati dall’Uomo in grado di compromettere l’esistenza stessa della civiltà.
Questi tre fattori hanno raggiunto un punto di convergenza nel corso della seconda metà del XX secolo.
La specie umana e la sua vulnerabilità
La pubblicazione del libro Primavera silenziosa di Rachel Carson (1962) viene generalmente considerato come il momento fondante della moderna ecologia. Si trattava di un’approfondita inchiesta sull’impatto di un uso indiscriminato di pesticidi, in particolare il DDT, sull’ecosistema, suggerendo un collegamento con la riduzione della presenza di uccelli nelle città, privati di una delle loro maggiori fonti di cibo, le zanzare, e in generale sui rischi di un utilizzo disinvolto dei prodotti chimici senza analizzarne preventivamente le conseguenze non solo per l’uomo, ma per tutte le altre specie viventi. Il libro ebbe un successo enorme e iniziò a diffondere la consapevolezza di una stretta interdipendenza tra l’Uomo e la natura, parti di un unico ecosistema estremamente fragile, dove un’azione apparentemente semplice come il rilascio di DDT attraverso una bomboletta spray può produrre conseguenze devastanti sul lungo periodo. Il DDT fu messo al bando nel 1972.
Nel 1966 Stewart Brand, all’epoca un giovanissimo ex studente di biologia e tra i futuri leader del movimento ambientalista e contestario, lanciò una campagna mediatica per convincere la NASA a rilasciare le immagini della Terra catturate dalle sonde automatiche lanciate negli anni precedenti, sulla base della convinzione che l’umanità avrebbe acquisito una nuova consapevolezza della vulnerabilità del pianeta una volta visto quanto piccolo appare dallo Spazio. La foto fu scattata dalla sonda ATS-3 nel 1967 e di nuovo dagli astronauti dell’Apollo 8 nel 1968, mentre spuntava al di sopra dell’orizzonte della Luna. Fu effettivamente un momento storico, che portò nel 1970 all’istituzione dell’Earth Day, l’evento più importante del primo movimento ambientalista, che adottò la foto della Terra vista dallo Spazio (“Blue Marble”, la biglia blu) come suo simbolo.
Nel 1969, nel corso di un convegno sulle origini della Terra a Princeton, il chimico britannico James Lovelock presentò per la prima volta quella che sarebbe diventata nota come “ipotesi Gaia”, sviluppata successivamente insieme alla biologa Lynn Margulis, che con il termine “Gaia” definiva sostanzialmente “un’entità complessa comprendente la biosfera della Terra, l’atmosfera, gli oceani e il suolo, l’insieme costituendo una retroazione (feedback) o un sistema cibernetico che cerca un ambiente fisico e chimico ottimale per la vita su questo pianeta”. Pubblicato per la prima volta nel 1979, Gaia: A New Look at Life on Earth divenne un best-seller. La Terra non veniva più vista come un mero sfondo immutabile delle attività umane, ma come un organismo autoregolantesi allo scopo di mantenere ottimali le condizioni per l’esistenza della biosfera. L’intervento dell’Uomo su di essa avrebbe rischiato di alterare e compromettere questo equilibrio, finendo per distruggere di conseguenza la stessa specie umana.
Quando Gaia uscì nelle librerie, cominciava a crescere la preoccupazione per una serie di rilevazioni che suggerivano una marcata e rapida riduzione della fascia di ozono nella stratosfera. La fascia di ozono ha un ruolo chiavo nella protezione della Terra dai raggi cosmici, e il “buco” che si scoprì sopra l’Antartide nella metà degli anni Ottanta provocò un autentico sgomento a livello mondiale. La causa fu individuata nei clorofluorocarburi (CFC), gas utilizzati negli anni Settanta per la refrigerazione e come propellenti per gli spray aerosol. Si ripresentava, in misura ancora più preoccupante, quello scenario delineato anni prima da Rachel Carson: un gesto innocuo come quello di spruzzarsi il deodorante poteva giungere a mettere a repentaglio la vita sulla Terra. Sull’onda di queste paure, nel 1987 il Protocollo di Montreal riuscì a mettere al bando i CFC a livello mondiale.
A queste preoccupazioni, negli anni Sessanta si aggiunsero altre legate strettamente alle dinamiche della popolazione umana. Dal 1900 al 1960 la popolazione mondiale era di fatto raddoppiata, balzando da 1,5 miliardi a circa 3 miliardi. La tendeva appariva in crescita e le prime proiezioni paventavano uno scenario da incubo, con una popolazione umana ben superiore alle risorse naturali del pianeta. Paul R. Ehlrich, biologo all’Università di Stanford, pubblicò nel 1968 un libro che fece scalpore, The Population Bomb. Ehlrich riprendeva le tesi di Malthus e prevedeva che, negli anni Settanta, centinaia di milioni di persone sarebbero morte a causa di carestie e della lotte per le risorse. La Rivoluzione verde, com’è noto, ha smentito queste fosche previsioni, ma tutto, in quegli anni, lasciava immaginare un’autentica apocalisse prodotta dalla sovrappopolazione fuori controllo. Isaac Asimov, proprio in quel decennio, si lanciò in una intensissima campagna mediatica a favore del controllo delle nascite, e film di fantascienza come Soylent Green misero il pubblico occidentale – in particolare americano – di fronte a scenari da incubo.
In questo quadro va ricordata la nascita del Club di Roma, nel 1968, che commissionò a un gruppo di esperti del MIT il celebre Rapporto sui limiti della crescita. Tutte queste preoccupazioni trovarono, nel Rapporto, una loro sistematizzazione e rielaborazione in chiave prospettica. Si dimostrava l’insostenibilità di una crescita perpetua per un pianeta dalle risorse finite come la Terra e i rischi esistenziali per la civiltà umana legati a questo trend esponenziale. Pur molto criticato all’epoca della sua pubblicazione, il Rapporto ebbe un ruolo decisivo nell’affermarsi dell’ambientalismo e della consapevolezza nell’interdipendenza dei sistemi: appariva chiara, all’opposto, la stretta e fatale connessione tra civiltà umana e risorse naturali, e il principio per cui l’esaurimento di tali risorse avrebbe compromesso inesorabilmente il futuro della civiltà.
Le estinzioni di massa
Il naturalista francese Georges Cuvier fu tra i primi sostenitori, agli inizi dell’Ottocento, del “catastrofismo”, la teoria secondo cui la storia della Terra sarebbe stata sconvolta periodicamente da enormi eventi catastrofici, tali da condurre numerose specie viventi del passato all’estinzione. La teoria non godette di grande credito: sebbene nel corso del secolo si accumulassero prove ormai inequivocabili dell’estinzione di numerose specie animali, tra cui i dinosauri, si prediligeva l’idea che le estinzioni fossero principalmente il frutto di una lunghissima e graduale evoluzione delle specie (teoria dell’uniformitarismo); d’altronde non emergevano prove geologiche tali da corroborare la tesi che immani catastrofi su scala globale avessero sconvolto, in epoche remote, il nostro pianeta. Fino agli Cinquanta del secolo scorso, i geologi escludevano decisamente l’idea che la Terra potesse essere colpita da asteroidi o altri corpi celesti. Anche tracce più evidenti come il Meteor Crater in Arizona venivano ricondotte ad antiche eruzioni vulcaniche.
Nel corso degli anni Sessanta si affermò, al contrario, una branca della geologia interessata allo studio degli impatti meteorici: Gene Shoemaker del California Institute of Technology a Pasadena individuò sul fondo del Meteor Crater diversi minerali rari quali coesite e stishovite che interpretò come il prodotto di un violento impatto da parte di un corpo esterno alla Terra, dal momento che quel tipo di minerali erano sconosciuti in natura e riprodotti all’epoca solamente alle enormi temperature e pressioni raggiungibili in laboratorio. Questi minerali vennero rivenuti da Shoemaker in un altro cratere in Baviera, insieme a diverse altre rocce frutto di parziali fusioni di materiali. Nello stesso periodo il paleontologo Norman Newell della Columbia University iniziò a sostenere l’esistenza di prove fossili di grandi estinzioni di massa.
Nel 1980 il fisico e Premio Nobel Luis Alvarez e il figlio, geologo, Walter Alvarez, pubblicarono su Science un articolo destinato a entrare nella storia, dal titolo “Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction”. In esso i due scienziati dimostravano l’esistenza di una singolare concentrazione di iridio – metallo comune nei meteoriti ma estremamente raro sulla superficie terrestre – negli strati geologici del limite K-T, come in gergo viene definito il confine tra periodo Cretaceo e Terziario, in cui si verificò la scomparsa dei dinosauri, 66 milioni di anni fa. Le quantità insolite di iridio vennero individuate in campioni raccolti in tutto il mondo (Italia, Danimarca, Nuova Zelanda). La loro ipotesi fu che un enorme meteorite avrebbe colpito la Terra in quell’epoca, provocando spaventosi sconvolgimenti su scala globale tali da condurre buona parte delle specie viventi dell’epoca, tra cui i dinosauri, all’estinzione. La tesi scatenò un dibattito ancora oggi non del tutto placato, ma con la successiva scoperta di un gigantesco cratere nel golfo del Messico, sotto la penisola dello Yucatan, fu infine individuata la pistola fumante. I carotaggi mostravano in quell’area uno strato di vetro, prodotto da un rapido processo di fusione e raffreddamento di rocce, in corrispondenza del limite K-T.
Da allora le estinzioni di massa sono diventate un tema centrale della ricerca paleontologica. Oggi si afferma l’esistenza di cinque estinzioni di massa (“Big Five”), benché la loro causa sia ancora oggetto di dibattito. Recentemente, le spiegazioni che tirano in ballo “cause extraterrestri” per buona parte se non tutte queste estinzioni hanno riguadagnato ampio credito, soprattutto in considerazione dei progressi nella ricerca astrofisica: l’esplosione di una supernova ravvicinata potrebbe essere stata causa dell’estinzione dell’Ordoviciano-Siluriano, 450 milioni di anni fa, impatti meteorici avrebbero provocato le estinzioni del Devoniano superiore (circa 377 milioni di anni fa), mentre un gigantesco impatto il cui cratere sarebbe variamente individuato in Australia o in Antartide, sarebbe la causa dell’estinzione di quasi il 96% delle specie viventi nel limite Permiano-Triassico (251 milioni di anni fa). Alle cause extraterrestri si affiancano altri tipi di spiegazioni, principalmente l’effetto di enormi eruzioni vulcaniche, con il conseguente effetto di raffreddamento del pianeta, e lunghissime glaciazioni. Si tratta, in generale, di eventi che sfuggono a una causa unificante, una teoria omnicomprensiva che ci permetterebbe, tra l’altro, di prevedere e anticipare futuri eventi estintivi; si è pertanto consolidata la percezione della vulnerabilità della vita sulla Terra, che in almeno un caso (l’estinzione del Permiano-Triassico) è andata molto vicina alla scomparsa totale.
Le indagini sugli impatti astronomici hanno permesso oggi di ricostruire numerosi eventi da impatto nella storia geologica e anche recente del pianeta, alimentando così la consapevolezza della pericolosità di meteoriti e asteroidi per la nostra civiltà. In particolare è stato stimato che, durante gli ultimi 600 milioni di anni, la Terra sia stata colpita da circa 60 corpi di origine extraterrestre con un diametro superiore ai 5 km, con una media puramente matematica di uno ogni 10 milioni di anni. Essendo l’ultimo grande impatto noto quello del limite K-T, si ritiene che il successivo impatto sia fortemente in ritardo.
La minaccia nucleare e il rischio tecnologico
Gli spaventosi effetti dell’esplosione dei due ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki nel 1945 costrinsero il mondo a familiarizzare con l’idea che esistessero armi in grado di distruggere intere città. La corsa agli armamenti raggiunse l’apice con i primi test di armi termonucleari, le cosiddette bombe H (o bombe all’idrogeno), agli inizi degli anni Cinquanta. Fin dai primi test atomici era noto l’effetto cosiddetto di “fallout”, ossia la ricaduta su un’area molto estesa delle radiazioni prodotte dalla detonazione dell’ordigno; ma le reali conseguenza del fallout divennero note alla comunità scientifica e al mondo intero all’indomani del test Bravo, nel 1954, che provocò un avvelenamento acuto da radiazioni nell’equipaggio della Daigo Fukuryu Maru, un peschereccio giapponese che transitava a oltre 130 chilometri dal punto della detonazione, l’atollo di Bikini. Il fallout dell’ordigno fu tale, tuttavia, da superare le previsioni degli scienziati ed estendersi su scala molto più ampia di quella evacuata. Quando l’Atomic Energy Commission sovrappose l’area di fallout a una carta degli Stati Uniti, con il centro di Washington D.C. come punto zero, si rese conto che, oltre alle vittime provocate dalla detonazione vera e propria, circa metà degli abitanti delle città di Washington, Baltimora e Filadelfia sarebbe rimasta uccisa dalle radiazioni. Churchill commentò: “La bomba all’idrogeno ci porta a proporzioni che fino a ieri erano rimaste confinate nel regno della fantasia e dell’immaginazione”. Dai calcoli dei servizi segreti britannici emerse che dieci bombe all’idrogeno esplose sul Regno Unito sarebbero bastate a provocare un fallout su scala nazionale, uccidendo un terzo della popolazione britannica quasi all’istante, ma soprattutto rendendo inservibili vastissime aree di terreno, costringendo i sopravvissuti ai rigori della carestia e della penuria di acqua potabile. Negli Stati Uniti la protezione civile suggerì ai cittadini dei sobborghi di costruire rifugi sotterranei e ammassare scorte di acqua e viveri nelle cantine. Se fino ad allora si sosteneva che, per sopravvivere a un attacco nucleare, bastasse “abbassarsi e coprirsi” durante la detonazione, ora si facevano i conti con le conseguenze sul lungo termine.
Mentre numerosi romanzi e film di fantascienza iniziavano a immaginare scenari post-atomici, in cui un’umanità ridotta all’osso e mutata dagli effetti delle radiazioni tentava, spesso invano, di ricostruire la decaduta civiltà tecnologica, diversi rapporti scientifici cominciarono a prendere in considerazione gli effetti climatici di una guerra nucleare su scala planetaria. Già in un rapporto della RAND del 1966 si sosteneva che la cenere sollevata da enormi incendi prodotti dalle detonazioni avrebbe coperto la luce solare nella stratosfera, con un meccanismo analogo a quello delle grandi eruzioni vulcaniche, i cui effetti sul raffreddamento delle temperature mondiali in epoche storiche erano già noti. La scoperta della riduzione dello strato di ozono suggerì anche ricerche che dimostrarono come numerose esplosioni termonucleari potessero provocare la scomparsa per qualche anno dello strato di ozono atmosferico, sottoponendo la superficie terrestre al bombardamento delle radiazioni ultraviolette, in grado di danneggiare irrimediabilmente il DNA delle specie viventi.
Nel 1983 apparve su Science un articolo dal titolo “Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions”, a firma di un gruppo di scienziati successivamente noti come TTAPS dalle loro iniziali (Richard Turco, Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack, Carl Sagan). Attraverso una simulazione al computer, gli autori mostrarono che una guerra nucleare su scala globale, tale da provocare la distruzione di circa 100 città, avrebbe comportato un rilascio tale di ceneri in atmosfera da coprire il 99% della luce solare per anni, con un crollo delle temperature estive tra i 20 e i 35° C, con conseguente perdita dei raccolti mondiali e morte per fame dei sopravvissuti. C’era un collegamento diretto tra questo scenario e quello diffuso solo alcuni anni prima dagli Alvarez relativo all’estinzione del limite K-T: di fatto, le armi termonucleari avrebbero prodotto gli stessi effetti dell’asteroide che uccide i dinosauri 66 milioni di anni prima. Quest’idea ebbe un’enorme risonanza: divenne chiaro a tutti che l’umanità disponeva ormai della capacità di estinguere la vita sulla Terra con le proprie stesse mani, grazie agli sviluppi del progresso tecnologico. Era la prima volta che un’invenzione prodotta dall’Uomo poteva provocarne anche l’estinzione. Da allora, i timori legati a uno sviluppo tecnologico incontrollato sono notevolmente cresciuti, mentre paradossalmente il rischio di una guerra nucleare, con la fine della guerra fredda, si sono sensibilmente ridotti. Armi batteriologiche e nanotecnologie hanno gradualmente preso il posto della bomba nucleare come potenziale strumento di un’estinzione di massa della specie umana.
A ciò si è aggiunta di recente una preoccupazione che inserisce in un’unica cornice omnicomprensiva le tre categorie di rischio discusse sopra: il cambiamento climatico. La consapevolezza che lo sviluppo industriale e tecnologico abbia prodotto un impatto sull’ambiente tale da aumentare significativamente le temperature su scala mondiale, stravolgendo al tempo stesso le dinamiche climatiche naturali, e mettendo a repentaglio di conseguenza non solo l’esistenza di numerose specie viventi, ma anche dell’umanità stessa, ci mette oggi di fronte ai pericoli di una “sesta estinzione di massa”, come viene definita da molti esperti: la prima estinzione di massa provocata non da fenomeni naturali, ma dall’affermazione della civiltà umana. I geologi dibattono oggi se individuare, a partire da una certa data, grossomodo intorno alla metà del secolo scorso, l’inizio di una nuova era geologica, definita “Antropocene”: l’umanità sarebbe infatti oggi in grado di lasciare un’impronta permanente sugli strati geologici a causa del suo impatto ambientale, individuabile nell’inusuale livello di radiazioni rilasciato nei decenni della guerra fredda a causa dei test atomici, nell’iperproduzione di plastiche, negli elevati livelli di inquinamento ambientale (soprattutto elevatissime concentrazioni di piombo e di anidride carbonica), e nel ritmo inusitato di estinzione di specie viventi solo negli ultimi decenni. Non a caso gli aggiornamenti del Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse “gestito” dal Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago fin dal 1947, hanno avvicinato maggiormente le lancette alla fatidica mezzanotte (simbolo della fine del mondo) a causa dell’aggravamento dei cambiamenti climatici, laddove fino al 2012 tutti i ritocchi delle lancette dell’Orologio erano collegati all’aumento o alla riduzione del solo rischio di guerra nucleare.
Per approfondire:
- Alvarez Walter, T.Rex and the Crater of Doom, 1997; tr. it. T.Rex e il createre dell’apocalisse, Mondadori, 1998.
- Brand Stewart, Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto, 2009; tr. it. Una cura per la Terra, Codice, 2010.
- Carson Rachel, Silent Spring, 1962; tr. it. Primavera silenziosa, Feltrinelli, 1999.
- Ehrlich Paul R., The Population Bomb, 1968.
- Kolbert Elizabeth, The Sixth Extinction, 2014; tr. it. La sesta estinzione, Neri Pozza, 2014.
- Lovelock James, Gaia: A New Look at Life on Earth, 1979; tr. it. Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri, 1981.
- Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. e Behrens W.W., The Limits to Growth, 1972; tr. it. I limiti dello sviluppo, Mondadori, 1972.
- Schlosser Eric, Command and Control, 2013; tr. it. Comando e controllo. Il mondo a un passo dall’apocalisse nucleare, Mondadori, 2015.
- Turco R.P., Toon O.B., Ackermann T.P., Pollack J.B. e Sagan C., “Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions”, Science, 222 (4630), 23 dicembre 1983.