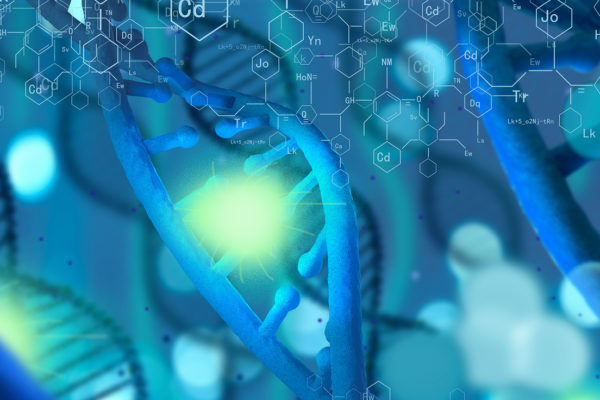Nella storia delle idee è sempre presente il dilemma se si debba cominciare la narrazione dalla comparsa del termine che indica il concetto, o se si debba invece cominciare dal concetto, a prescindere dall’esistenza di un termine convenzionalmente accettato per significarlo. Possiamo dire che per ogni idea c’è una preistoria (prima della parola) e una storia (dopo la parola). In questo articolo ci occuperemo soltanto della storia della “tecnoetica”. Anche se riflessioni di carattere etico o morale – termini che a noi piace utilizzare come sinonimi, in ossequio agli etimi – sull’utilizzo di determinate tecniche, oggetti artificiali, macchine, o utensili, sono verosimilmente antiche quanto l’uomo, è relativamente nuova l’esigenza di organizzare queste riflessioni in un campo di studio definito, con una denominazione convenzionalmente accettata e il necessario corredo di istituzioni accademiche, corsi universitari, pubblicazioni e simposi internazionali. Uno dei termini-ombrello che è stato proposto per indicare l’insieme di queste riflessioni, e che ha ricevuto un apprezzabile consenso, è “tecnoetica”. Tutto fa pensare che quest’area di ricerca sia avviata a diventare una disciplina autonoma, simile alla bioetica e ad essa complementare.
Nascita del termine “tecnoetica”
Il primo uso di cui si ha traccia del termine “tecnoetica” (o, meglio, di un suo equivalente in lingua inglese) risale al 1971. È l’ingegnere chimico e teologo Norman Faramelli a introdurre il termine technethics, senza la “o”, per indicare un’etica generale della tecnologia. Essendo Faramelli un teologo e sacerdote della Chiesa episcopale, il quadro teorico da lui proposto per valutare la costruzione e l’uso di nuove tecnologie è quello della dottrina cristiana. Due anni più tardi, il termine “technethics” viene proposto nuovamente, nel Britannica Book of the Year 1973, con il seguente significato: «The responsible use of science, technology and ethics in a society shaped by technology» (“L’uso responsabile della scienza, della tecnologia e dell’etica in una società informata dalla tecnologia”). L’autore della voce enciclopedica non fa alcun riferimento a Faramelli e, pertanto, non sappiamo se si tratti di una proposta indipendente o di un esempio di “obliteration by incorporation”, espressione coniata da Robert K. Merton (1968: 27-28) per indicare il vezzo letterario di non citare più la fonte originale, quando l’idea incorporata nel proprio testo è considerata generalmente accettata.
Nel 1974, compare per la prima volta il termine “technoethics”, con la “o”, ovvero quello ora in uso nel mondo anglosassone. È il filosofo argentino-canadese Mario Bunge a coniarlo. Il termine e il concetto sono originalmente presentati al Symposium on Ethics in an Age of Pervasive Technology che si tiene tra il 21 e il 25 dicembre 1974 al Technion – Israel Institute of Technology. La relazione di Bunge compare, in varie forme, su tre diverse pubblicazioni: la prima volta, nel 1975, sulla rivista Philosophic Exchange; poi, nel 1977, sulla rivista Monist; e, infine, tre anni più tardi, negli atti della conferenza del Technion, curati da Melvin Kransberg. Bunge, più che a se stesso o ai suoi colleghi filosofi, sembra voler assegnare in primis agli ingegneri (preferiamo questo termine, anche se quello utilizzato da Bunge è in realtà “technologists”, forse traducibile con “tecnologi”, esperti di tecnologie), il compito di forgiare un’adeguata tecnoetica. Nelle battute iniziali del suo articolo, leggiamo che verranno esaminate «alcune delle responsabilità speciali dell’ingegnere, nella nostra epoca, caratterizzata dalla presenza pervasiva – e, ahimè, troppo spesso perversa – della tecnologia». La tesi difesa da Bunge è che l’ingegnere, proprio come chiunque altro, «è personalmente responsabile per qualsiasi cosa faccia ed è responsabile nei confronti di tutta l’umanità, non solo dei suoi datori di lavoro». In altre parole, l’ingegnere «ha il dovere di affrontare, analizzare e risolvere i propri problemi morali» ed è, oltretutto, particolarmente attrezzato per farlo, «poiché può affrontare i problemi morali, e persino la teoria della moralità, cioè l’etica, con l’aiuto di un approccio e di un insieme di strumenti estranei alla maggior parte dei filosofi e tuttavia in grado di forgiare la tecnoetica che i filosofi non si sono degnati di elaborare» (Bunge 1975).
Per Bunge, ingegneri e manager, a causa del loro crescente potere, hanno ormai acquisito responsabilità morali e politiche di gran lunga superiori a quelle che investono altri soggetti sociali. Essi devono coscientemente farsi carico di queste responsabilità e soprattutto comprendere che non possono fare affidamento sulla teoria morale tradizionale, per risolvere i problemi. La teoria morale tradizionale è “sottosviluppata”, proprio perché ha per lo più ignorato i problemi speciali posti dalla scienza e dalla tecnologia. L’approccio tecnoetico di Bunge è dunque più radicale rispetto a quello di Faramelli. Non si tratta soltanto di mantenere la produzione e l’uso di oggetti tecnologici nei limiti della tradizionale visione etica del mondo occidentale, in particolare di quella cristiana, ma di riscrivere ex novo l’etica, prendendo atto che il mondo è completamente cambiato per effetto della rivoluzione industriale e non c’è più comportamento che esuli dalla dimensione tecnologica.