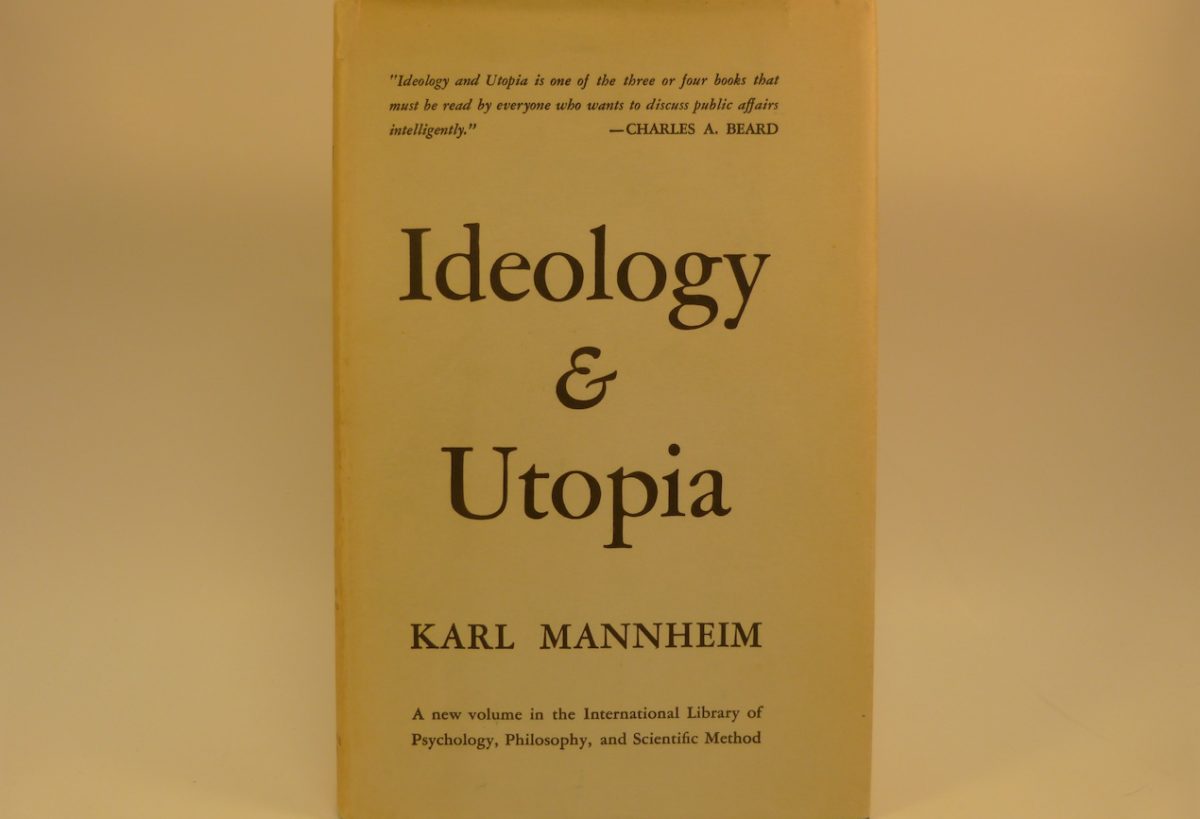L’utopia: nel DNA dei Futures Studies
I Futures Studies hanno un elemento di utopia nel loro DNA. Si tratta di un elemento imprescindibile, con il quale i teorici della disciplina non hanno esitato a confrontarsi, evidenziandone, con onestà e senza remore, gli aspetti controversi. L’utopia è parte integrante dell’immaginazione dei futuri, né potrebbe essere altrimenti, considerando come le prime notizie che si hanno di studi sul futuro risalgano ai primi del Novecento, in anni ancora impregnati della incrollabile fiducia nel progresso scientifico che aveva caratterizzato tutto il XIX secolo. Per la prima volta, l’utopia viene vista come qualcosa di realizzabile nel tempo, come logica conseguenza del processo/progresso storico; non la si concepisce più in quanto astrazione, modello di una società mai concretizzabile, per le sue stesse caratteristiche, nel tempo e nello spazio. Basti pensare, per avere una prova di questo nuovo clima mentale – e su fronti ideologici[1] totalmente opposti – alla fiducia nel raggiungimento futuro dell’état positif teorizzato da Auguste Comte, così come della società egualitaria teorizzata, nello stesso secolo, da Karl Marx. Una temperie culturale non priva di ricadute nel XX secolo. Periodo in cui, spesso, si cercò di ottenere una società “perfetta”, spesso forzando la mano agli eventi, con conseguenze (troppo spesso) disastrose.
E qui il cerchio si chiude, se consideriamo come i Futures Studies trovino la loro vera ragion d’essere, si sviluppino e strutturino proprio sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, quando la scoperta degli orrori dei campi di concentramento, la consapevolezza della potenza devastante della bomba atomica, e poi gli anni della Guerra Fredda, privarono l’umanità di ogni residuo di ottocentesca illusione. Il progresso non era un processo inarrestabile; era possibile un uso “cattivo” della scienza; il rischio di cancellare l’umanità dalla faccia della terra con una guerra nucleare era tutt’altro che remoto. A fronte della consapevolezza degli errori fatti, restava, tuttavia, la coscienza, riprendendo il pensiero Ernst Bloch (1918), che l’utopia è “ciò che ancora non è”, ma potrà essere. Perdendo il suo antico alone di irrealizzabilità, essa acquisisce, di fatto, una sorta di funzione anticipatrice; qualcosa di più, di molto di più di un modello ideale, dunque. Per lunghi anni, gli studiosi di Futures Studies – e comunque chi si esprimesse a favore di una visione differente rispetto al mainstream “un solo futuro – un solo modo per arrivarci”, veniva tacciato di essere un visionario – e questa, come la parola “utopista” veniva usata, nei loro confronti, in termini pressoché dispregiativi.
Utopista e visionario era considerato, in Italia, l’industriale Adriano Olivetti. Così come utopista e visionario era considerato Aurelio Peccei. Se vogliamo però considerare la realtà dei fatti, si trattava di persone che operavano, ad altissimi livelli, in ambito industriale: uomini che non si limitavano, dunque, a sognare le cose, ma le facevano. Conseguivano risultati per cui erano disposti a lavorare duramente. Pochi anni più tardi, nel contesto accademico degli anni Settanta, il matematico Bruno de Finetti trae le fila di una lunga ed importante riflessione teorica, sviluppata nel corso dei seminari estivi del CIME, da lui diretti. Una delle raccolte di saggi che usciranno da tale esperienza (de Finetti, 1976) avrà un titolo molto emblematico: Dall’Utopia all’Alternativa (1971-1976). Questo per dire come, nel contesto futurologico italiano, l’Utopia si è coniugata non tanto con l’ipotesi di una prassi tipicamente rivoluzionaria, quanto, semmai, con l’idea di una messa in discussione totale delle idee alla base dell’esistente, nell’ipotesi che esso potesse essere cambiato, anche radicalmente (così come era cambiata la fabbrica di Olivetti) se cambiava l’idea che ne era alla base, il suo principio epistemico.