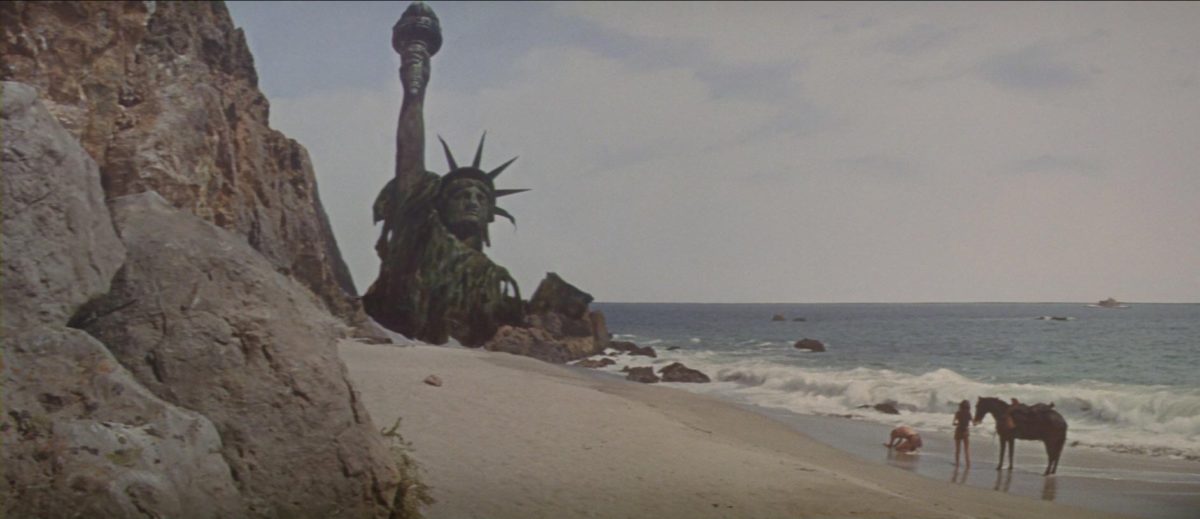Non solo i fisici e i filosofi, ma anche i sociologici ragionano sul problema del tempo. Lo ha dimostrato il convegno “From memories to the future” organizzato dalla European Sociological Association e dall’Associazione Italiana di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” il 4 e 5 giugno; un evento al quale anche l’Italian Institute for the Future ha preso parte, per l’importanza dei temi trattati e il tentativo, unico nel suo genere finora, almeno in Italia, di costruire una sociologia del futuro attraverso l’interazione con i temi della sociologia della memoria (disciplina, questa, ben più consolidata della prima). Passato, presente e futuro sono strettamente interconnessi, per cui non può esserci futuro senza conoscenza del passato: e questo è un dato assodato. D’altro canto, le nostre aspettative sul futuro hanno impatto diretto sul presente, e ciò in qualche modo mette in crisi la freccia entropica che dal passato procede inesorabilmente verso il futuro. Ma, e qui sta l’idea più interessante, esplorata da molti dei contributi del convegno, il futuro può avere un impatto anche sul passato, sulla memoria, modificandola o addirittura cancellandola. Un problema, come vedremo, molto meno astratto e filosofico di quanto si potrebbe immaginare.
Prendiamo in considerazione un esempio banale. Un post virale che gira recentemente su Facebook mostra la differenza tra le foto scattate da una macchina fotografica con rullino e uno smartphone. Con la macchina con rullino si potevano scattare 24 foto, se ne sviluppavano 24 e sempre 24 restano nel nostro album, pronte per essere viste e riviste a ogni occasione. Con lo smartphone non è affatto raro scattare, in pochi mesi, più di 1000 foto; ma di queste generalmente non ne stampiamo nessuna e, tra qualche anno, non ce ne resterà ugualmente nessuna da sfogliare. Magari le salviamo sul PC, o sul Cloud. Ma restano lì, ce ne dimentichiamo e non le andiamo più a rivedere. Benvenuti nell’epoca dell’accelerazione e dell’overload di informazione. Un problema sottolineato recentemente da molti studiosi e rilanciato, nel corso del convegno di Napoli, da Umberto Pagano, docente di Sociologia dei processi economici all’Università di Catanzaro e studioso dei problemi dell’accelerazione e della compressione del tempo sperimentata dalla società tardo-moderna. Le tesi di Pagano sono analoghe a quelle esposte da Hartmut Rosa nel suo libro Accelerazione e alienazione, appena pubblicato in Italia da Einaudi, che sta generando un certo dibattito nei circoli intellettuali. Sarà probabilmente l’uso della parola “alienazione”, che fa suonare un campanello tra i pensatori nostrani a cui invece il più moderno concetto di “accelerazione” lascia indifferenti. Le tesi di Pagano e Rosa sono apparentemente semplici: la nostra società è vittima di un’alienazione sociale prodotta dall’accelerazione, intesa sia nel tradizionale senso tecnologico – il nuovo sistema operativo rilasciato ogni anno, lo smartphone da buttare dopo uno o due anni, il Blu-ray che ha sostituito il DVD cha ha sostituito il VHS – sia nel più ampio senso sociale. Tutto accelera: le emissioni di gas serra in atmosfera, la speranza di vita, la popolazione mondiale, la crescita del PIL mondiale, la durata dei governi, dei contratti di lavoro, persino degli allenatori delle squadra di calcio, esonerati dopo pochi mesi se non portano risultati.
Il risultato lo conosciamo tutti. Il multitasking, per esempio, ci costringe a fare tante cose contemporaneamente per rispondere ai continui stimoli, al carico di lavoro che cresce in continuazione, e ciò nonostante il fatto che l’accelerazione tecnologica dovrebbe metterci a disposizione più tempo (per esempio, per andare da Napoli a Roma fino a qualche anno fa ci volevano due ore e mezza; oggi ci si riesce in un’ora, e si guadagna un’ora e mezza. Ma a nessuno sembra davvero di aver guadagnato tempo da vivere). Cosa sta succedendo? Succede che ci sentiamo sempre meno in grado di controllare il nostro tempo e il nostro posto nel mondo. Da qui la crescita dei casi di depressione e di sindrome da burnout, l’esaurimento nervoso che colpisce le persone più stressate, a causa dell’accelerazione in cui sono perennemente immersi. Da qui anche il fenomeno dei NEET, i giovani che non riescono a tenersi al passo in una società ultra-competitiva e che decidono di ritirarsi dalla competizione mondiale. Come spiegava già nel 2001 il sociologo Adolfo Fattori (membro del Comitato scientifico dell’IIF) nel suo libro Memorie dal futuro, “con il sopraggiungere della tarda modernità la spinta al futuro si esaurisce, sostituita da un senso di disorientamento e spaesamento che si possono ricondurre agli effetti di quell’accelerazione del mutamento che pare far ‘superare’ il futuro prima ancora che si realizzi, riflettendosi pesantemente anche sul nostro senso di identità: identità sempre più vaghe, infantili, fungibili, virtuali, legate ad un presente senza sviluppo, in spazi sempre più indeterminati”. L’alienazione prodotta dall’accelerazione impedisce al singolo, come alla collettività, di fermarsi a ragionare su quanto sta facendo. Riduce il tempo a un presentismo spinto, estremo, che cancella qualsiasi pianificazione del futuro come qualsiasi riflessione sul passato. L’accelerazione, dunque, cancella la stessa memoria. Non stampiamo più foto: le scattiamo, le guardiamo una volta, e basta.
Quanto l’accelerazione rischi di cancellare la nostra memoria, lo ha spiegato molto bene, durante il convegno di Napoli, Silvia Pezzoli, docente di Sociologia dei processi culturali all’Università di Firenze e studiosa dell’elaborazione del lutto nella società contemporanea. Secondo Pezzoli, la morte è ormai sempre più rimossa dall’orizzonte di possibilità preso in considerazione dall’individuo moderno. La nostra continua immersione nella routine quotidiana non concede spazi al lutto per la perdita di una persona cara; l’accelerazione sociale non ci consente pause, non permette di fermarsi ed elaborare, per giorni, settimane o mesi, la perdita di un famigliare o di un amico. Pertanto, la morte scompare dai discorsi sociali come dalla sfera dell’individuo. Quando però la perdita riguarda persone particolarmente care, o per legami sentimentali molto complessi o per perdite traumatiche (ad esempio la morte di un figlio), ecco che andiamo in crisi: non possiamo far finta di nulla, ma non possediamo nemmeno più gli strumenti che ci consentono di elaborare il lutto, perché la società, che prima metteva in atto tutta una serie di meccanismi per facilitare questa elaborazione, li ha completamente rimossi. La Pezzoli, che ha lavorato nei gruppi di auto-mutuo-aiuto per le persone traumatizzate da eventi luttuosi, osserva che l’esigenza prioritaria è selezionare quella parte della memoria riguardante la persona estinta da conservare per il futuro. La paura maggiore riguarda la possibilità di dimenticare ciò che riguarda la persona estinta, dai ricordi ad essa legati alla sua stessa fisionomia: una possibilità reale in un’epoca senza memoria.
La rimozione della morte nella società tardo-moderna è parte integrante di quel fenomeno di rimozione della memoria – individuale e collettiva – prodotta dall’accelerazione sociale. Recentemente questo problema ha catturato l’attenzione degli architetti del futuro, ossia i guru della Silicon Valley, che hanno iniziato a preoccuparsi del problema dell’oblio digitale legato a due fenomeni: l’obsolescenza tecnologica e la volatilità della memoria digitale. Il primo caso, l’obsolescenza, può essere esemplificato dal fatto che una marea di informazione oggi non è più disponibile perché racchiusa in microfilm o floppy disk, di cui non esistono più in commercio lettori. Il secondo caso può essere spiegato chiedendoci che fine abbiano fatto tutte le conservazioni che giovani e meno giovani si sono scambiati fino a pochi anni fa sul popolare servizio di instant messaging MSN Messanger. La risposta è: sono irrecuperabili, scomparse con la chiusura del servizio. Poco male, potremmo dire: nel migliore dei casi si trattava di conversazioni adolescenziali di poco peso. Ma estendiamo il problema a Facebook, utilizzato oggi da più di un miliardo di utenti per comunicare. Un giorno non molto lontano, l’estrazione di informazione prodotta da un utente Facebook potrebbe avere grande importanza per finalità biografiche. Per ricostruire la storia di uno scienziato, di un artista o di un politico scomparso, dovremmo recuperare tutto ciò che ha pubblicato su Facebook (o su Twitter), sia pubblicamente che privatamente, esattamente come un tempo si faceva recuperando i diari e le lettere inviate ai corrispondenti. Ma se Facebook chiuderà o si evolverà, che fine faranno tutte quelle comunicazioni? Andranno perdute. Spesso ci capita di perdere, per problemi legati ai server o ai clienti di posta, l’archivio di email degli anni precedenti. Ciò comporta un grave problema di perdita di memoria storica di noi stessi; problema che, moltiplicato per tutti gli utenti di Internet, diventa un problema di memoria collettiva.
Vinton Cerf, uno dei padri di Internet, oggi chief Internet evangelist di Google, ha lanciato un grido d’allarme sull’argomento che ha risuonato in tutto il mondo. Ma, da buon ingegnere convinto che la soluzione risieda nella tecnologia, ha suggerito di lavorare di più su software in grado di emulare programmi obsoleti, archivi Internet dove conservare vecchie pagine web (come fa il servizio Internet Archive), e trasparenza dei codici sorgente dei sistemi operativi. Ma il problema della perdita di memoria nell’era digitale può essere risolto solo attraverso una riappropriazione individuale e collettiva del tempo necessario a elaborare il proprio passato, conferendo nuovamente senso alla memoria, rimossa dall’accelerazione sociale e tecnologica. Pertanto, la soluzione non passa per la tecnologia ma, come giustamente ha suggerito, sottotraccia, il convegno di Napoli, per la sociologia: la soluzione sta in un nuovo modo di costruire i rapporti umani. Alla domanda su quali correttivi apportare alla società dell’accelerazione, Umberto Pagano ha rifuggito ipotesi tecnoluddiste, rappresentate dalle facili tentazioni del rallentamento e della decrescita, e suggerito, filosoficamente, un recupero della lezione di Heidegger sull’essere-per-la-morte: solo riportando la consapevolezza della morte entro il nostro orizzonte di aspettativa potremmo tornare a dare senso al nostro agire, immergendolo nel mare del tempo per sfuggire al naufragio nel presentismo. La finitezza della vita, in sostanza, ci permette di pianificare individualmente e collettivamente, valorizzando la memoria e le radici storiche, guadando al lungo termine invece che al breve.
Suggestione sicuramente interessante, Ma anche di difficile realizzazione. Un’idea affascinante, su cui si potrebbe iniziare a lavorare, è stata suggerita, nel corso del convegno di Napoli, da Carlos López Galviz della School of Advanced Study all’Università di Londra: un “archivio dei futuri non realizzati”, che conservi tutti i progetti – urbanistici, architettonici, tecnologici, sociali, politici – elaborati nel corso dei decenni e mai realizzati. Un simile archivio permetterebbe, da un lato, di costruire una sorta di “museo del futuro”, che analizzi il modo in cui le diverse società, nel corso della storia recente, hanno immaginato e pensato il futuro dal loro punto di vista; e, dall’altro, consentirebbe di non perdere la “memoria del futuro”, poiché da quelle idee e progetti potrebbe emergere qualcosa che, irrealizzabile all’epoca, potrebbe oggi essere riportato in auge. Ci permettiamo di aggiungere qui un’altra idea, un’altra possibile soluzione da cui spesso l’Italian Institute for the Future ha tratto ispirazione, quella teorizzata dalla Long Now Foundation di San Francisco, secondo cui bisogna recuperare il senso del “lungo termine” attraverso tutta una serie di iniziative che sensibilizzino l’uomo contemporaneo alla consapevolezza dei grandi cicli del tempo, di cui la sua vita non è che una parte infinitesimale. Recuperando questa visione del long now, il “lungo presente”, potremmo riuscire a rapportarci meglio al futuro, capendo che molte grandi sfide che ci attendono – ad esempio il contrasto al cambiamento climatico – hanno bisogno di un impegno protratto per un tempo lunghissimo per essere vinte, mentre la nostra logica di breve termine ci impedisce di affrontarle con successo. La Long Now sta lavorando alla realizzazione di un Orologio del Lungo Presente nelle montagne dell’Arizona: uno strumento in grado di funzionare anche senza energia elettrica, basato solo sulla meccanica, destinato in teoria a durare millenni. Un orologio che non indica i secondi, i minuti, o le ore, ma i giorni, i mesi lunari, gli anni solari, fino all’ultimo livello possibile, la precessione degli equinozi, un ciclo della durata di 25.784 anni. Un simile progetto, secondo quanto scrive Stewart Brand, co-fondatore della Long Now, nel suo libro Il lungo presente. Tempo e responsabilità (1999), aiuterà “a far comprendere alla gente il valore della conoscenza nel lungo periodo”, impendendo che l’umanità diventi “obsoleta fino a cessare di esistere, non essendo più un grado di scorrere le antiche raccolte di dati sull’aria e sul mare per trovare tendenze che si rendono visibili solo guardano ai secoli e ai millenni”.