![]()
Il messaggio che ci arriva dappertutto è chiaro: al mondo come lo conosciamo oggi sta per accadere qualcosa di davvero brutto. Dalla destra ci viene detto che “l’Occidente” e la “Civiltà Giudeo-Cristiana” sono tra le grinfie di infedeli stranieri ed estremisti locali incappucciati. Il declinismo di sinistra biascica di colpi di stato, regimi di sorveglianza e l’inevitabile – seppur inafferrabile – fine del capitalismo. Per il profetico sociologo tedesco Wolfgang Streeck, la scelta è tra capitalismo e democrazia. Come in molti atteggiamenti declinisti, Streeck prospetta il purgatorio o il paradiso. Come tanti prima di lui, Streeck insiste nel fatto che abbiamo varcato il vestibolo dell’inferno. “Prima che il capitalismo vada all’inferno”, sostiene in Come finirà il capitalismo? (2016), “nel futuro che possiamo prevedere rimarrà in un limbo, morto o sul punto di morire a causa di una overdose di se stesso, ma sarà ancora in giro, perché nessuno avrà il coraggio di spostare il suo corpo in decadenza dalla strada.”
In effetti, l’idea del declino è una delle cose su cui gli estremisti di destra e sinistra concordano. Julian Assange, avatar del populismo apocalittico, riceve complimenti sia da neo-nazisti che da crociati della giustizia sociale. Ha fatto notare a un reporter come il potere americano, fonte dei mali del mondo, fosse in declino come quello di Roma. “Questo potrebbe essere l’inizio”, ha sussurrato con un sorriso, ripetendo la cosa come il mantra di un angelo vendicativo.
Il declino di Roma è un precedente importantissimo. Gli storici del mondo hanno giocato la loro parte come profeti dell’apocalisse. Lo stesso anno in cui veniva pubblicato il primo volume della Storia del declino e della caduta dell’impero romano (1776) dello storico inglese Edward Gibbon, i coloni Americani dicevano addio ai loro padroni; alcuni lo hanno letto come un presagio. La Prima guerra mondiale ha portato il “finismo” nell’età moderna. La sua rappresentazione più celebre è Il declino dell’Occidente (1918) dello storico tedesco Oswald Spengler. La carneficina nelle Fiandre e la pandemia influenzale – che spazzarono via il 5% della popolazione mondiale – resero Il declino dell’Occidente più che tempestivo. Spengler aggiunse dell’altro: predisse che entro la fine del secolo la civiltà occidentale per salvarsi avrebbe avuto bisogno di un esecutivo con poteri enormi, un’idea di cui da allora gli autocrati si sono felicemente appropriati.
È quasi parte della condizione moderna aspettarsi che la festa abbia prima o poi fine, più prima che poi. Quel che cambia è in che modo arriverà la fine. Il grande livellatore sarà un cataclisma biblico? O sarà qualcosa di più graduale, come la carestia Maltusiana o un crollo della morale?
La nostra epoca declinista è degna di nota per una cosa in particolare. Gli occidentali non sono i soli a essere in pericolo; grazie alla globalizzazione, lo sono anche gli altri. Siamo tutti insieme, come specie, in questo casino; le nostre catene di approvvigionamento mondiali e il cambiamento climatico ci assicurano che siamo tutti pronti a una sesta estinzione di massa. Dovremmo preoccuparci meno del nostro stile di vita e più della vita stessa.
I declinismi condividono alcune caratteristiche. Hanno più seguito in tempi di agitazione e incertezza. Sono anche inclini a pensare che i gironi dell’inferno possano essere evitati solo con una grande catarsi o con una grande figura carismatica.
Ma soprattutto: tutti ignorano i segnali di miglioramento che indicano soluzioni meno drastiche per scampare alle difficoltà. I declinisti hanno un grande punto cieco perché sono attratti dall’azzardare alternative totalizzanti e onnicomprensive al grigiore monotono delle soluzioni modeste.
I declinisti sostengono di vedere il big picture, il quadro d’insieme. I loro ritratti sono grandiosi, sussuntivi, totali. Considerate uno dei principali best seller di sempre, I limiti dello sviluppo (1972) del Club di Roma. Con più di 30 milioni di copie vendute in 30 lingue, questo “Progetto sulla complicata situazione dell’umanità” diede agli allarmati lettori un ritratto di morte, delineato con una fiducia sommessa nei confronti dei “feedback” e delle “interazioni”. Il libro aveva molto in comune con il buon reverendo Thomas Malthus, inclusa la fissazione nei confronti dei rendimenti decrescenti. Ossessionato dal declino della superficie arabile, Malthus non riusciva a vedere fonti di rendimenti crescenti – almeno non subito. Alla fine alcuni dei suoi amici riuscirono a convincerlo che le macchine e il colonialismo avevano risolto il problema del poco cibo per troppe bocche; edizioni successive del suo Saggio sul principio di popolazione (1798) testimoniano un percorso tortuoso verso la comprensione di tale visione. Nello stesso modo, gli analisti di sistema al Massachussets Institute of Technology (MIT) hanno simulato il mondo intero, ma non sono riusciti a integrare piccoli tasselli come l’ingegnosità, il problem-solving e l’adattamento, alcuni dei quali avrebbero avuto l’effetto perverso di sbloccare così tante fonti di carbone che alcune generazioni dopo avremmo cominciato a friggere il pianeta!
Una voce contraria negli anni Settanta fu quella di Albert O Hirschman. Hischman era preoccupato dal richiamo delle narrazioni apocalittiche. Le predizioni cupe, avvertiva, possono nascondere agli osservatori del “big picture” tendenze contrarie, esempi positivi e possibili soluzioni. C’è una ragione: i declinisti confondono le crescenti difficoltà dovute al cambiamento con indizi che suggerirebbero la fine di interi sistemi. Il declinismo non concepisce la possibilità che dietro il ridimensionamento dei vecchi metodi possano essercene di nuovi che si stanno facendo strada.
Perché la fascinazione del declinismo, se la storia raramente si conforma alle previsioni? Per Hirschman, il declinismo è riconducibile a uno stile profetico che fa presa sugli intellettuali attratti da spiegazioni “fondamentaliste” e che preferiscono guardare a cause incontrollabili dei problemi sociali. Per i rivoluzionari, quel che ci aspetta è un’alternativa utopica. Per i reazionari, quel che ci attende è una distopia. Il risultato è un modo di pensare “antagonistico”, la credenza che la storia oscilli da un sistema grande, integrato e onnicomprensivo a un altro. Rispetto ad avanzamenti modesti, compromessi e concessioni – che noia! – la grandiosa visione di una rivoluzione completa del sistema esercita molto fascino.
La predilezione per gli affreschi grandiosi comporta dei rischi. L’incapacità di notare successi inattesi e segnali di speranza nella frenesia di cambiare tutto può spesso portare più distruzione che costruzione. Hirschman aveva previsto il prezzo da pagare per il declinismo. Crescendo nella Germania di Weimar, vide il suo paese cadere preda di una “trappola ideologica”, e dividersi tra gli estremi nei primi anni Trenta, quando comunisti e fascisti decisero di distruggere la repubblica nell’intento di realizzare le loro rispettive utopie – mentre non andavano d’accordo su tutto il resto.
Decenni dopo, Hirschman osservò come i latinoamericani fossero disperati per la prospettiva di una riforma democratica. Il loro scivolare in quella che egli definì “fracasomania” – la propensione a vedere fallimenti ovunque – precluse miglioramenti incrementali e successi sui quali non si nutrivano molte speranze. E la ragione era che il declino dell’America latina aveva trascinato con sé il riformismo democratico. Il risultato fu che si ripose più fiducia in visioni ancora più estreme e nel desiderio di azioni dirette. Gli studenti dell’Università di Buenos Aires si unirono alle guerriglie urbane. Dall’altra parte dello spettro politico, i reazionari argentini lamentavano la fine della civiltà occidentale e dettero vita agli squadroni della morte paramilitari. Quando infine nel marzo del 1976 ebbe luogo il colpo di stato, la giunta militare si autodefinì “processo di riorganizzazione nazionale”. Mentre amici di una vita si nascondevano o scappavano, Hirschman ebbe degli episodi di déjà-vu. Cominciò ad avere incubi sulle trappole ideologiche della sua gioventù. Quando i suoi editori tedeschi gli chiesero di scrivere una prefazione speciale alla traduzione in tedesco del suo classico Lealtà, defezione, protesta (1970), ricordi della Berlino del 1933 cominciarono a riaffiorare nella sua mente.
Il problema del declinismo è che conferma le virtù delle nostre ambiziose, impossibili soluzioni a problemi di estrema rilevanza. Conferma inoltre le delusioni che persistono nei cambiamenti che abbiamo realmente conseguito. Ciò non vuol dire che non esistano problemi di difficile soluzione. Ma considerarli come prova di una fine ineluttabile può impoverire la nostra immaginazione attirandoci verso le sirene del cambiamento totale o del fatalismo.
L’articolo originale è apparso su Aeon. Traduzione di Bruno Formicola.





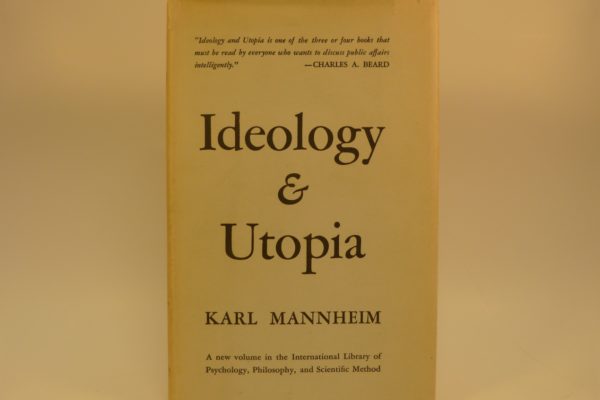







Concordo con la testi dell’articolo. La paura del futuro va combattuta alla radice.